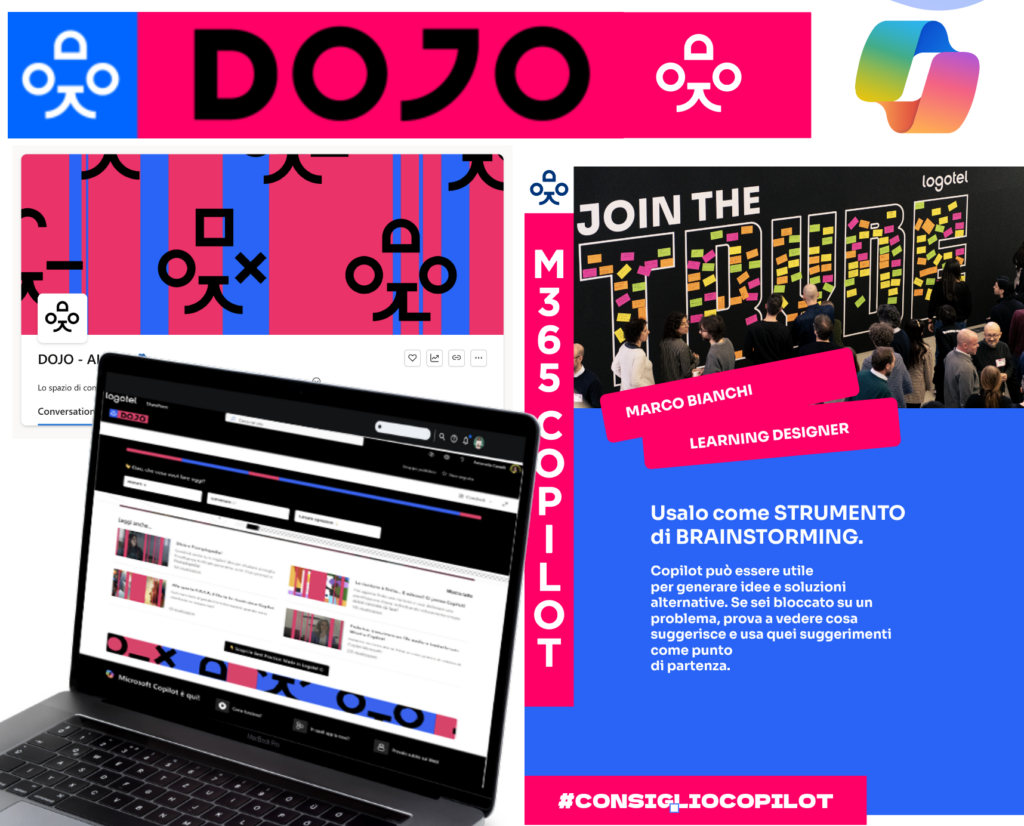Claudio Magni è Head of Development di Italgas, azienda leader nella distribuzione del gas con oltre 185 anni di storia, protagonista della transizione energetica a livello europeo. Claudio ha collaborato con Logotel per il progetto Dojo, una community di adozione dell’AI generativa per far scalare e promuovere l’utilizzo di Microsoft Copilot all’interno di Italgas, costruita all’interno della suite M365 già presente all’interno dell’organizzazione.
In questa intervista per il magazine di Logotel abbiamo toccato con lui diversi temi: le skill per gestire il cambiamento, come vincere le resistenze che le persone hanno nei confronti dell’AI, l’efficacia e i vantaggi di un approccio community-driven per l’adozione e il training dell’intelligenza artificiale generativa in azienda, la dimensione collettiva e collaborativa con l’AI.
Le soft skill cruciali per guidare la trasformazione AI
D. Italgas è leader nella transizione energetica, che è una delle grandi trasformazioni in atto in quest’epoca di mutamenti. Un’altra è sicuramente costituita dall’intelligenza artificiale. Quali sono le sfide per le persone che affrontano queste trasformazioni? Quali skill, attitudini, comportamenti dovrebbero potenziare per essere parte attiva delle trasformazioni e non subirle?
R. Credo che l’intelligenza artificiale generativa sia la principale forza trasformativa del modo di lavorare di tutte le nostre persone.
In Italgas abbiamo introdotto già alcuni anni fa un nuovo modello di leadership e stiamo continuando a espanderlo, focalizzandoci su quelle che sono le skill – in particolare le soft skill – che risultano sempre più necessarie per gestire il cambiamento.
In realtà, se vediamo quali sono le competenze strategiche che riteniamo importanti, ci accorgiamo che si tratta di skill già presenti nei modelli tradizionali di leadership, che però oggi vengono enfatizzate in maniera più diretta.
Quindi non stiamo cambiando il modello di skill necessarie, ma ve ne sono alcune che con l’AI, e quindi in un contesto in continuo mutamento, risultano più importanti, come ad esempio la curiosità, il pensiero laterale, una spiccata intelligenza emotiva e sociale, l’apprendimento continuo e una comunicazione collaborativa.
D. Parlando di integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno delle organizzazioni, ci sono ancora delle resistenze nelle persone rispetto a queste tecnologie? Se sì, quali sono?
R. Una delle conseguenze dell’introduzione massiva dell’intelligenza artificiale nelle organizzazioni è il reskilling delle persone. C’è chi è abituato a fare da 20 anni una determinata attività e domani magari dovrà imparare a farla diversamente. Questo è uno degli aspetti principali che identifichiamo come HR e genera paura e timore.
Per questo, una delle scelte che abbiamo fatto in Italgas è stata quella di gestire la trasformazione legata all’intelligenza artificiale non come una funzione IT, ma in maniera cross tra IT e HR. La nostra direzione HR si chiama People innovation transformation, abbraccia pure i temi legati all’intelligenza artificiale e ha al suo interno anche una divisione dedicata alla Generative AI, proprio perché riteniamo che tutto ciò che l’AI comporta sulla trasformazione del modo di lavorare non sia più solo un problema della funzione IT, ma una questione cross funzionale.
È con questo approccio che possiamo riuscire a ridurre i timori delle persone, che è uno degli obiettivi che ci poniamo come HR.
Perché la formazione tradizionale sull’AI copre solo il 10% dell’apprendimento
D. Menzionavi il fatto che l’intelligenza artificiale è qualcosa che probabilmente non smetterà mai di evolversi: ci sono sempre nuovi tool, nuove funzioni. Il reskilling delle persone deve essere continuo, e questo significa operare un cambio di mentalità e anche un cambiamento su come formare le persone.
R. Uno degli aspetti principali per cui abbiamo scelto di portare avanti l’approccio all’AI adoption community-driven di Dojo, è che la gestione dell’intelligenza artificiale generativa in un certo senso non è qualcosa che si insegna alle persone. Sono le persone che devono imparare a utilizzarla in autonomia e vederne veramente il valore. In questo senso, un approccio tradizionale di formazione sull’intelligenza artificiale copre fino al 10% dell’apprendimento.
La decisione di implementare il Dojo è nata quindi anche dalla scarsa efficacia degli approcci tradizionali che avevamo provato in precedenza, come ad esempio corsi specifici sul prompting. Certo, anche questi corsi e l’approccio tradizionale servono, ma uno dei vantaggi del Dojo, e quindi di un approccio community-driven, è quello di stimolare la curiosità e la dimensione di scambio e relazione fra le persone.
Alcune delle skill più importanti per quest’epoca di trasformazioni, come la creatività critica, l’apprendimento continuo, l’agilità del cambiamento, sono fondamentali per utilizzare uno strumento che consente di produrre degli output in autonomia.
Il Dojo permette che le persone sperimentino e diano avvio a delle attività da sole e quindi stimola l’apprendimento continuo, soprattutto inteso come autoapprendimento, un aspetto che in una formazione tradizionale non è così marcato.
Dal singolo alla community: come nascono gli agenti AI nel Dojo
D. Ci piacerebbe soffermarci sul processo di creazione di agenti AI all’interno del Dojo. Partendo dall’apprendimento individuale, attraverso il confronto nella community emergono bisogni che sono più di contesto o di processo, legati magari a una particolare famiglia professionale. Ci sembra un bell’esempio di come uno spazio di collaborazione e scambio possa generare innovazione.
R. Il processo di creazione degli agenti all’interno del Dojo è uno degli aspetti che ci ha stupiti di più. Disporre di una “palestra” come il Dojo, uno spazio protetto in cui sperimentare, dà la possibilità alle colleghe e ai colleghi di lanciarsi, mettere a terra idee, provare senza paura a fare delle proposte e trasformarle poi in agenti.
È ovvio poi che tra le soluzioni proposte ve ne sono magari alcune più naive, oltre ad altre molto più originali che stiamo sviluppando. Ma l’aspetto su cui voglio concentrarmi è che, con un approccio tradizionale, probabilmente le persone non avrebbero mai trovato il coraggio di proporre le loro idee. È proprio questo che è importante: mettere le persone nella condizione di proporre un’idea, anche se risulta banale. Perché è questo processo – la proposta, l’ascolto – che contribuisce ad abbassare paure e timori legati all’intelligenza artificiale, a partire dalla paura di perdere il posto di lavoro, e ad accrescere la fiducia sia rispetto alla tecnologia, sia rispetto all’ecosistema, ai colleghi con cui collaborare.
D. Spesso gli outcome di un progetto – soprattutto quando si parla di community – vanno oltre Kpi numerici e si manifestano in relazioni di valore, interazioni qualitative. Ci puoi fare qualche esempio concreto di dinamiche positive che hai visto nascere nell’ambito del Dojo?
R. La prima cosa che mi ha sorpreso in positivo è che ci sia tanta gente che sperimenta proattivamente. Non ci sono obblighi, né reward specifici; le persone sperimentano perché appunto si sentono in un ambiente estremamente protetto, c’è fiducia e mettono a terra delle idee che prima avrebbero avuto difficoltà a proporre.
Gli agenti che effettivamente sono nati all’interno del Dojo sono tutti in una fase molto embrionale, per cui ancora non so quantificare il loro ritorno. Però sicuramente hanno creato una sorta di pipeline delle necessità interne, e in questa maniera ci rendiamo conto anche che diverse funzioni e diverse persone hanno alla fine necessità simili.
Un altro elemento di sorpresa in positivo ha a che fare con il reskilling delle persone. Tramite il Dojo riesci a individuare delle persone che sono più propense a ricoprire dei ruoli e fare dei lavori che un domani potrebbero servire alla nostra organizzazione. E la cosa sorprendente è che si tratta di persone che normalmente non avresti mai potuto individuare.
D. Quindi è come se la community Dojo fosse un catalizzatore per l’innovazione interna.
R. Esatto. Non nasce con questo scopo, però prende questa piega. E queste dinamiche poi vanno oltre il perimetro della community. Per esempio, trovi persone che discutono di ciò che hanno sperimentato anche su Linkedin.
Oppure trovi persone che ricoprono determinati ruoli ma che poi, dopo essersi confrontate nel Dojo, si sono appassionate allo sviluppo di agenti in ambiti lavorativi nei quali non avremmo mai individuato le loro expertise.
Indirettamente, come HR, stiamo ottenendo delle informazioni molto importanti sulle nostre persone, che potrebbero aiutarci se in futuro dovessimo valutare dei cambi di ruolo.
Faccio un esempio concreto: qualche anno fa c’è stata la corsa ai Data Scientist all’interno delle aziende, che ha portato a fare esplodere il mercato, con la conseguenza che è stato quasi impossibile trovare questa tipologia di figure.
Secondo me, il Dojo e altri approcci simili che sviluppano le potenzialità nascoste delle persone possono permetterti di anticipare i competitor, piuttosto che rincorrerli. Concludo con un altro esempio: se in futuro ci sarà la corsa ai prompt engineer, magari nel frattempo noi lo avremo già individuato in-house e sapremo a chi rivolgerci.
Return on Impact: quando il valore di un progetto supera i numeri
D. Recentemente, insieme a Daniele Cerra e Matteo Ordanini di Logotel avete portato il caso Dojo-Italgas sul palco della AI WEEK. E in quell’occasione hai utilizzato un termine: più che un Return on investment, con il Dojo senti di aver ottenuto un Return on impact. Cosa significa?
R. Nel campo delle iniziative legate all’intelligenza artificiale generativa, il ROI tradizionale è a volte difficile da quantificare. D’altro canto, l’impatto che hanno iniziative come il Dojo sulla quotidianità è molto più importante, perché ti insegnano a pensare in maniera diversa, sviluppano il lateral thinking, cambiano il modo di lavorare delle persone.
Anche se nel Dojo ci sono kpi tradizionali di misurazione, numerici, spesso sono i kpi non numerici che ti sorprendono di più. Ad esempio, un collega che si occupa di AI attraverso ciò che sta emergendo dalla community sta ottenendo informazioni utilissime sulla direzione da seguire per gli sviluppi successivi. Questo è un Kpi più difficile da quantificare, ma di maggior valore rispetto a un Kpi standard come le ore di formazione svolte.
Il Dojo come palestra permanente per l’evoluzione tecnologica
D. Come è stato accolto il Dojo internamente, dalle persone che vi hanno partecipato?
R. È stato accolto molto positivamente, perché appunto abbatte il timore e la paura legati all’intelligenza artificiale. C’è una sorta di paradosso con l’AI, perché a volte capita che delle persone si debbano riunire per disegnare come l’intelligenza artificiale potrà stravolgere il loro lavoro. Col Dojo riesci a farlo in maniera molto giocosa, facendo capire tutto ciò che c’è di buono dietro una tecnologia così disruptive come l’intelligenza artificiale.
D. Come potrebbe evolversi il progetto?
R. Mi piace immaginare il Dojo come una palestra sempre disponibile per accompagnare l’evoluzione continua nell’ambito della tecnologia, perché è un ottimo modo per veicolare le novità, ti dà una mano a diffondere in maniera sempre più ampia le innovazioni o i diversi utilizzi di determinate applicazioni e strumenti.