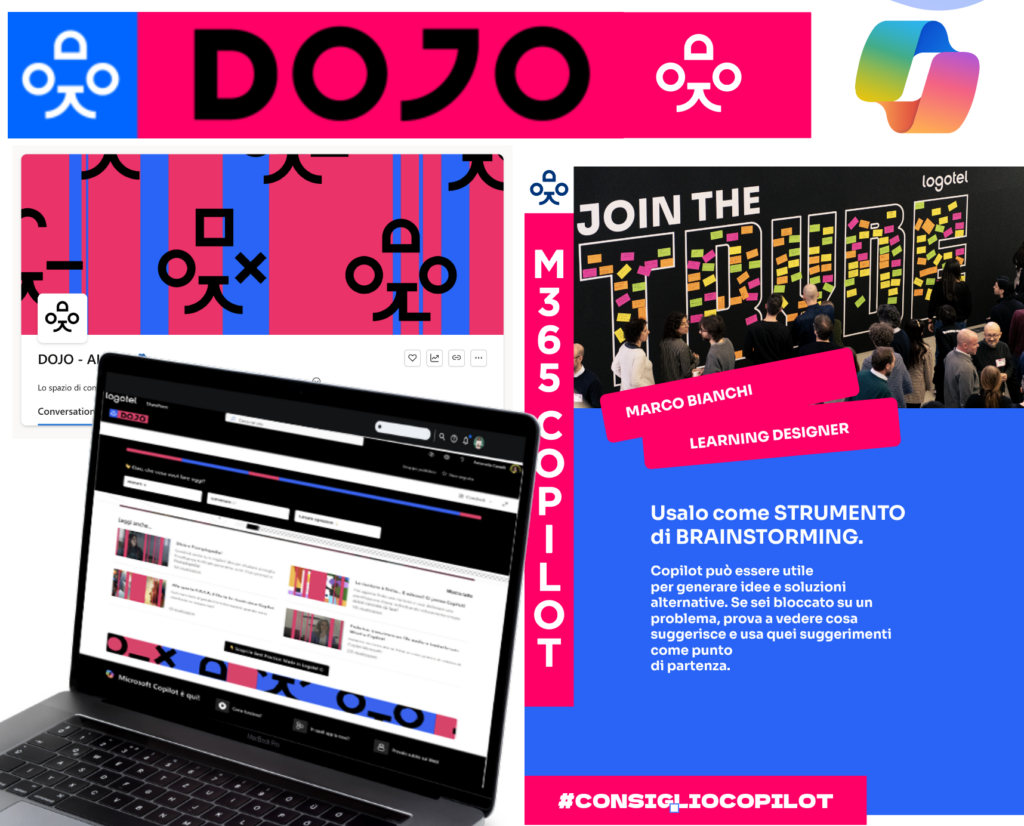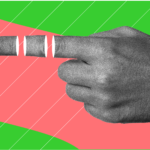C’è stato un momento in cui sembrava che tutto potesse cambiare. La pandemia aveva riscritto le regole del gioco, rivelando nuove possibilità per l’organizzazione del lavoro. Lo smart working prometteva libertà, flessibilità e nuovi equilibri tra vita personale e professionale.
Ma cinque anni dopo, quel sogno si è incrinato. Non siamo tornati del tutto al passato, ma nemmeno abbiamo costruito davvero un nuovo presente. Siamo rimasti in una terra di mezzo. E molti, semplicemente, si sono stancati di aspettare.
Questo è lo scenario in cui si inserisce il concetto di Great detachment, un nuovo fenomeno di cui parlano a livello internazionale articoli e report e che arriva dopo la Great resignation, il Great regret e il quiet quitting.
Di quest’ultimo, il Great detachment è un po’ l’evoluzione. Non si tratta più solo di persone che abbandonano il proprio posto di lavoro, ma di un malessere più profondo: quello di chi si sente emotivamente scollegato dalla propria attività, ma non ha né la forza né le condizioni per cambiare. È una disillusione silenziosa e strisciante, fatta di apatia, fatica emotiva, mancanza di senso.
Secondo Gallup, istituto di ricerca che per primo ha identificato e dato l’etichetta a questo fenomeno, siamo di fronte a un paradosso. Da un lato, il turnover si è rallentato rispetto agli anni più turbolenti del post-Covid. Dall’altro, le persone sono meno coinvolte, meno soddisfatte e più propense a cercare nuove opportunità. Solo che oggi cambiare lavoro è diventato più rischioso: l’inflazione, l’instabilità economica e la difficoltà di trovare aziende davvero diverse scoraggiano il salto. E così si rimane. Ma si resta a metà.
I segnali del Great detachment
I dati parlano chiaro. Solo il 10% dei lavoratori italiani si sente bene nel contesto organizzativo in cui opera, secondo l’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano. Il 17% è pienamente coinvolto. Il 14% si definisce quiet quitter: presenti, ma disposti a fare il minimo indispensabile. E la quota di chi, pur insoddisfatto, non sta più nemmeno cercando attivamente un nuovo impiego è in aumento.
Sono tutti segnali di una disillusione, di una disconnessione, le cui ragioni sono molteplici. Alcune sono sistemiche. Dopo il 2020, la maggior parte delle aziende ha vissuto cambiamenti organizzativi profondi e accelerati: fusioni, ristrutturazioni, tagli di budget, nuove tecnologie, nuovi strumenti, nuovi ruoli.
In molti casi, tutto questo è avvenuto senza una strategia chiara, senza una narrazione condivisa. I team sono diventati più fragili, i capi più oberati, le persone più sole. In molti casi si è smarrito il senso, che “non è solo il perché che differenzia, ma l’anima che muove e attiva” aziende e organizzazioni, come ha scritto Nicola Favini, CEO della Independent design company Logotel, nell’ultimo numero di Weconomy, progetto di ricerca open source sull’economia collaborativa.
Altre cause riguardano il lavoro ibrido e remoto, oggi ampiamente diffuso ma ancora male interpretato. Come dimostra una recente indagine pubblicata su Harvard Business Review, la gestione tradizionale del personale – pensata per un mondo in presenza – semplicemente non funziona più. Le aspettative non sono chiare, la collaborazione tra team si inceppa, le relazioni si raffreddano, i feedback si perdono. Il lavoro diventa un insieme di task da completare, scollegati da uno scopo più ampio.
Non è un caso che le due leve fondamentali che oggi spiegano l’impegno lavorativo – chiarezza delle aspettative e connessione con la missione aziendale – siano in netto calo. Solo il 45% dei lavoratori sa cosa ci si aspetta davvero da lui. Solo il 30% sente di contribuire a qualcosa che abbia senso. Ed è proprio in questo vuoto di significato che nasce la grande disillusione.
I nuovi disillusi: non solo burnout, ma mancanza di senso
Il Great Detachment non è solo stanchezza, né semplice mancanza di motivazione. È una forma più sottile di alienazione. È il sentirsi inutili anche quando si è produttivi. È il non riconoscersi più nei valori dell’organizzazione, nel modo in cui si prendono le decisioni, nelle priorità strategiche.
A soffrirne di più sono i più giovani, come i lavoratori della GenZ, e i profili a basso contatto sociale, come coloro che lavorano in full remote. Ma in realtà il fenomeno è trasversale. Riguarda chi lavora in aziende che cambiano troppo in fretta, senza comunicare. Riguarda i nuovi assunti che faticano a capire le regole del gioco, perché nessuno gliele spiega. Riguarda i middle manager, chiamati a fare da cuscinetto tra richieste irrealistiche e risorse limitate.
È una crisi del significato prima ancora che dell’organizzazione.
Il tempo dell’AI e della solitudine
Paradossalmente, l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro – che dovrebbe liberare tempo e aumentare il valore del lavoro umano – rischia di accentuare questo distacco. Secondo i dati dell’Osservatorio del Politecnico, un lavoratore su tre utilizza strumenti di AI, guadagnando in media 30 minuti al giorno. Ma questo tempo viene spesso riempito con ulteriore produttività, non con migliori relazioni, senso o apprendimento.
Il problema non è l’AI in sé, ma il fatto che venga ancora adottata in modo disorganico, senza un disegno strategico, spesso tramite strumenti personali non forniti dall’azienda. L’AI può supportare la qualità del lavoro, ma non può sostituire ciò che tiene insieme una comunità di persone: la fiducia, lo scopo condiviso, il senso di appartenenza.
Come si risponde al distacco?
In un contesto così complesso, la risposta delle aziende non può essere semplicemente riportare tutti in ufficio o inserire nuovi tool. Serve un cambio di prospettiva. Secondo Gallup, le priorità sono due: ripristinare la chiarezza delle aspettative e rafforzare la connessione con la missione aziendale. Non si tratta di grandi rivoluzioni, ma di tornare a ciò che conta.
Chiarezza significa stabilire, insieme alle persone, che cosa ci si aspetta davvero, in che ordine di priorità, con quali strumenti e con quale impatto sul carico di lavoro. Significa rendere visibili i criteri di valutazione, ma anche gli spazi per crescere e sperimentare. E significa farlo in un dialogo continuo, non in un’unica call annuale.
Connessione con la missione significa rendere esplicito il “perché” di ciò che si fa. Collegare i risultati ai valori. Riconoscere il contributo di ciascuno. Celebrare i successi come comunità. Aiutare le persone a raccontarsi il proprio lavoro come qualcosa che genera valore.
Le aziende che ci stanno riuscendo – spesso quelle che adottano modelli organizzativi più orizzontali e skill-based – mostrano già segnali incoraggianti. Nelle organizzazioni che ragionano sulle competenze – le cosiddette skill-based organization – il coinvolgimento sale dal 17% al 42%, il benessere dal 10% al 18%, e la propensione a lasciare l’azienda diminuisce.
Oltre la retorica del purpose
Non basta però una dichiarazione d’intenti o una campagna interna di employer branding. Serve autenticità. Serve una leadership capace di ascoltare e di riconoscere la complessità del momento. Serve spazio per il dialogo, per il confronto intergenerazionale, per il riconoscimento reciproco.
Il futuro del lavoro non si gioca solo sulla tecnologia, né sulla produttività. Si gioca sulla qualità delle relazioni, sull’inclusività dei processi decisionali, sulla capacità di costruire luoghi di lavoro che non siano solo efficienti, ma anche significativi. Perché il rischio vero non è solo perdere talenti, ma lasciare che restino disillusi.