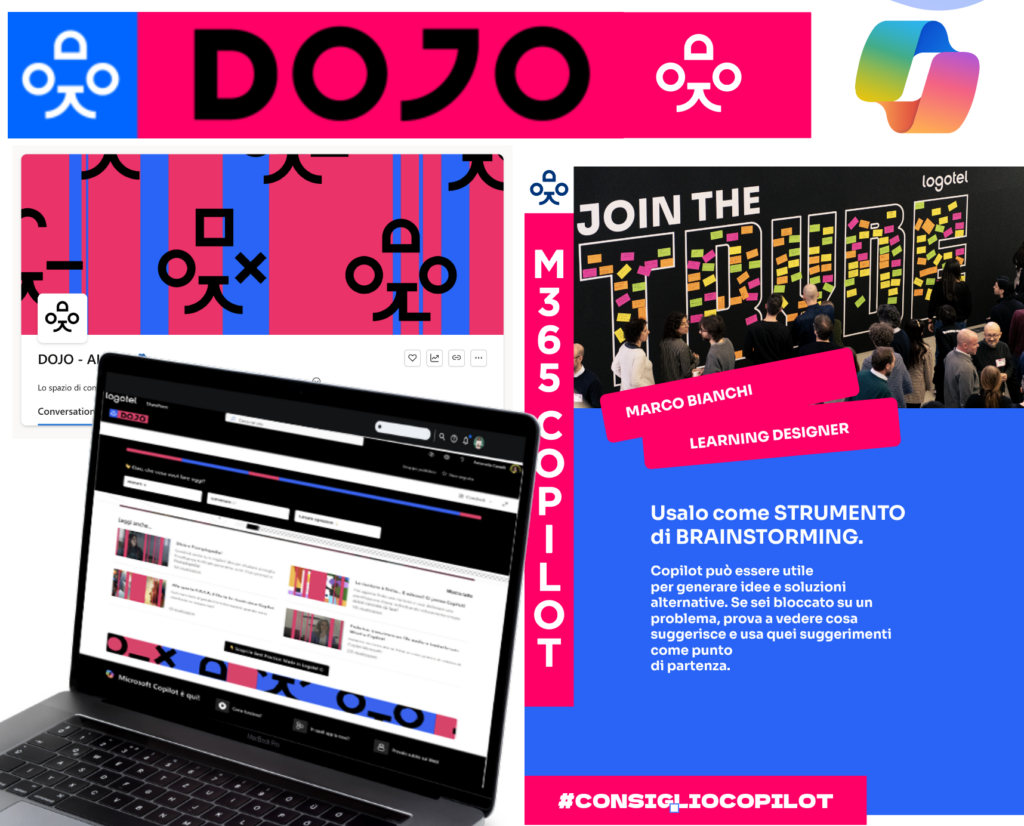Negli ultimi anni, il mondo del lavoro ha subito trasformazioni profonde.
Anche se alcune sono iniziate già da diverso tempo, il vero spartiacque è stata la pandemia. Le misure emergenziali per il Covid hanno spinto aziende e pubbliche amministrazioni a sperimentare nuove formule di flessibilità: dallo smart working al lavoro ibrido, fino a modelli più radicali come la settimana lavorativa di quattro giorni.
Quest’ultima non è più un’utopia da visionari, ma un tassello concreto di quella trasformazione che rientra nell’ampia etichetta dei new ways of working. Un esperimento concreto che coinvolge migliaia di persone in diversi Paesi, anche in Italia, producendo risultati che stanno stimolando un dibattito globale.
Ma questa soluzione funziona davvero? Cerchiamo di capirlo in questo articolo.
Un’idea antica che diventa attuale
Il concetto di ridurre i giorni lavorativi non è nuovo. In Italia le 40 ore lavorative settimanali – la norma in quasi tutti i settori – sono state stabilite a livello legislativo nel 1997, anche se sono state conquistate, nei fatti, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. E proprio agli anni Settanta risalgono le prime proposte verso ulteriori riduzioni dell’orario lavorativo, legate alla produttività crescente delle economie industriali.
All’epoca, però, prevalse un paradigma diverso: più tecnologia significava più output, e dunque più lavoro. Oggi la prospettiva si è ribaltata: con l’automazione e l’intelligenza artificiale che promette più produttività in meno tempo, la sfida non è estrarre sempre più ore dai lavoratori, ma garantire maggior benessere, più employee engagement – che in Italia e altrove è molto basso – e maggiore sostenibilità del lavoro stesso.
La settimana corta torna così al centro del dibattito non come concessione, ma come leva strategica per affrontare burnout, malessere lavorativo e fenomeni recenti come il great detachment, quella sensazione diffusa di distacco emotivo dal proprio lavoro che sempre più studi registrano a livello globale.
Le evidenze dei grandi trial
Il punto di svolta è arrivato con i grandi esperimenti su larga scala. Uno dei più importanti è stato quello condotto nel Regno Unito nel 2022: oltre 60 aziende e circa 3.000 lavoratori hanno testato per sei mesi uno dei modelli più diffusi della settimana lavorativa di quattro giorni, la formula 100-80-100 (100% della retribuzione, 80% del tempo, con almeno 100% della produttività).
I risultati hanno mostrato un netto miglioramento del benessere, con riduzioni significative dei livelli di stress e una maggiore soddisfazione personale e familiare. Molte aziende hanno scelto di proseguire con il modello anche dopo la fine della sperimentazione.
Più recentemente, a evidenziare i vantaggi della settimana lavorativa è stata l’economista e sociologa del Boston College Juliet B. Schor. Il suo ultimo libro, Four Days a Week: The Life-Changing Solution for Reducing Employee Stress, Improving Well-Being, and Working Smarter (Harper Business), raccoglie i risultati del più ampio studio sulla settimana lavorativa di quattro giorni mai realizzato, che a partire dal 2022 ha coinvolto 245 organizzazioni e 8.700 dipendenti in una varietà di settori, demografie e Paesi.
In un’intervista pubblicata sulla MIT Sloan Management Review, la professoressa ha affermato che i risultati ottenuti dalle aziende che hanno sperimentato la settimana corta sono stati sorprendentemente positivi.
Tutti i 20 indicatori di benessere analizzati hanno mostrato miglioramenti. L’intensità del lavoro non è aumentata e le connessioni sociali tra colleghi sono rimaste forti, suggerendo che le organizzazioni hanno trovato modi più efficienti di lavorare piuttosto che semplicemente accelerare i ritmi.
Inoltre, la maggior parte delle aziende ha riportato buoni risultati di produttività e molte hanno visto aumentare la produttività auto-dichiarata. Un dato particolarmente significativo è che, al termine del primo anno di sperimentazione, il 90% delle aziende studiate ha continuato a utilizzare la settimana di quattro giorni, dimostrando la sostenibilità del modello.
Sono dati che ribaltano un pregiudizio radicato: meno giorni lavorativi non significano automaticamente meno output.
Perché funziona: la questione della produttività
Il cuore della questione è proprio qui: si può fare di più lavorando di meno? Le evidenze sopra citate sembrano suggerire di sì, almeno in molti contesti.
La riduzione dei giorni lavorativi porta inevitabilmente a una razionalizzazione delle attività: meno meeting inutili – e, di conseguenza, meno meeting hangover –, più concentrazione, maggiore priorità ai compiti a valore.
In altre parole, la settimana corta costringe organizzazioni e individui a distinguere tra ciò che è davvero essenziale e ciò che è superfluo. Si riduce il tempo perso in task ripetitivi o burocratici, si alleggerisce il carico mentale e si recupera energia.
Il benessere come fattore competitivo
La four-day week non è solo una questione di efficienza, ma di qualità della vita. I dati lo confermano: chi lavora quattro giorni anziché cinque dorme meglio, ha più tempo da dedicare alla famiglia, può coltivare interessi personali. Questo non è un dettaglio, perché benessere e performance sono correlati.
Ridurre il burnout significa meno assenze, meno turnover, più engagement. E in un mercato del lavoro caratterizzato dal talent shortage, offrire un modello più sostenibile diventa anche un vantaggio competitivo nell’attrazione e nella retention dei talenti.
Non sorprende che, tra le aziende che hanno adottato la settimana corta, la soddisfazione dei dipendenti sia cresciuta a livelli record.
I limiti e le sfide da affrontare
Naturalmente, non tutto è rose e fiori. La settimana lavorativa di quattro giorni presenta sfide organizzative che non possono essere ignorate. Alcuni settori – come la sanità, il retail o la logistica – richiedono una presenza costante e non possono ridurre i giorni senza ripensare radicalmente i turni.
C’è poi il tema delle disuguaglianze: lavori più creativi o digitali sono spesso più adatti al modello, mentre chi opera in mansioni manuali o di servizio rischia di restarne escluso.
Inoltre, c’è il rischio che, per garantire gli stessi risultati in meno tempo, i ritmi di lavoro diventino troppo intensi, vanificando i benefici sul benessere. Un’eventualità che nelle aziende coinvolte nello studio del Boston College non si è verificata, ma che non si può escludere del tutto.
Infine, vale per settimana lavorativa di quattro giorni la stessa considerazione fatta per il lavoro ibrido: non si tratta di una formula magica che, a priori, garantisce il successo – in questo caso, mantenere o aumentare la produttività e incrementare il benessere delle persone –, ma occorre sempre partire dai diversi contesti aziendali e dagli specifici bisogni.
Un nuovo contratto psicologico
Ciò che rende davvero interessante la settimana corta non è solo la riduzione delle ore, ma il nuovo patto implicito che propone tra azienda e dipendenti. Non si lavora meno per fare meno, ma per lavorare meglio.
Il focus si sposta dal tempo trascorso in ufficio ai risultati ottenuti. Uno shift che, in realtà, dovrebbe anche essere al centro dello smart working vero e proprio, che invece in molti casi si riduce a essere una remotizzazione del lavoro svolto in ufficio.
È un cambio di paradigma che richiede fiducia, chiarezza sugli obiettivi, capacità di misurare la performance in modo diverso. In questo senso, la four-day week è anche un esperimento culturale. Sfida modelli gerarchici e metriche del passato, spinge a ridisegnare i processi, ad affidarsi di più all’autonomia dei team e alla responsabilizzazione individuale.
Inserita in un contesto più ampio, la settimana corta si collega ad altre trasformazioni in atto: il lavoro ibrido, l’adozione massiccia della GenAI, la crescente centralità del benessere psicologico, le esigenze delle nuove generazioni.
Come ogni trasformazione, va accompagnata. E per questo motivo – come suggerisce l’Independent design company Logotel, che dal 1993 accompagna imprese e organizzazioni a cogliere il senso di trasformazioni e innovazioni – bisogna prestare particolare attenzione all’adoption.
Una volta che la direzione è decisa e tracciata, occorre fare in modo che tutte le persone coinvolte decidano di essere parte del cambiamento e modifichino i loro comportamenti per rendere piacevole, produttiva e sostenibile la trasformazione.
Conclusione: funziona davvero?
Alla domanda iniziale – la settimana lavorativa di 4 giorni funziona? – la risposta è: in molti casi sì, ma non per tutti e non senza ripensare i modelli organizzativi. Non si tratta di una soluzione universale, ma deve essere frutto di precise scelte strategiche e accompagnata da percorsi di trasformazione condivisi e sostenibili.
È un modello che può funzionare se le aziende ridefiniscono processi e metriche, se lavorano sulla fiducia e sulla cultura, se mettono davvero al centro il benessere delle persone. Può funzionare se risponde con efficacia a un bisogno profondo di equilibrio e di senso, che le nuove generazioni di lavoratori stanno portando con forza nelle organizzazioni.
In Italia, aziende come Intesa Sanpaolo, Lamborghini, Luxottica e anche alcune pubbliche amministrazioni hanno iniziato a sperimentare questa nuova modalità lavorativa. Come ogni novità, però, occorrerà sicuramente del tempo per trarre delle conclusioni solide e capire se potrà diventare la nuova normalità lavorativa.