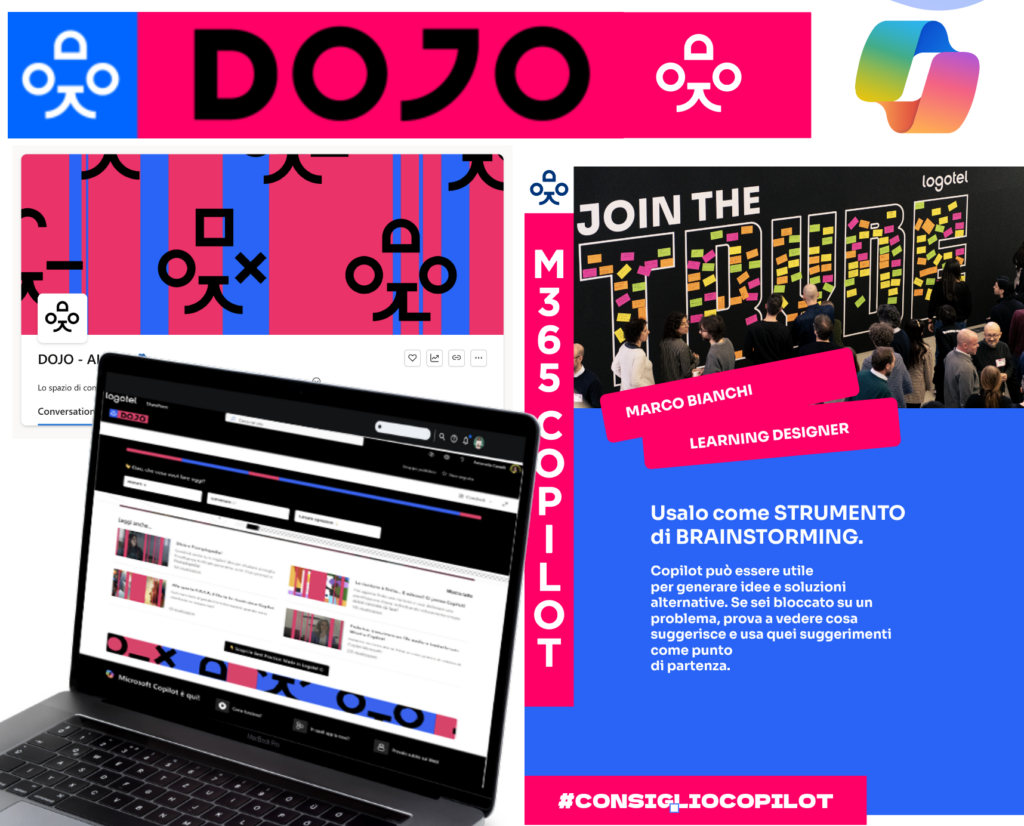Nel 2023 Forbes si chiedeva se la DEI (acronimo per Diversity, equity e inclusion) fosse ufficialmente morta. Due anni dopo, sulla stessa testata è apparso un altro articolo – a firma della medesima giornalista – che smonta il “mito” della morte della DEI. Anzi: nel testo si afferma che sette aziende su otto stanno portando avanti i propri sforzi in ambito DEI nel 2025.
Queste poche righe mostrano come il dibattito su tutto ciò che concerne le tematiche che riguardano la diversità, l’equità e l’inclusione – sia sul lavoro sia, più in generale, nella società – sia più vivo che mai.
Vale lo stesso per uno dei terreni su cui la DEI si radica nel concreto: il linguaggio ampio o inclusivo. Anche in questo ambito si segnalano spinte contrastanti. Pensiamo solo a quanto avvenuto in Italia negli ultimi anni. Da un lato, abbiamo visto la prima Presidente del Consiglio donna, Giorgia Meloni, che ha scelto nei documenti ufficiali di farsi appellare come “il” Presidente del Consiglio.
Dall’altro, abbiamo assistito a proteste come quella dello studente Gabriele Lodetti, che nel giugno 2023 ha scelto di utilizzare la schwa, grafismo simbolo della comunità non binaria, nel suo tema di maturità.
Il modo in cui parliamo e le parole che utilizziamo per relazionarci con le altre persone creano e plasmano la nostra realtà, influenzando il modo in cui viviamo, lavoriamo, collaboriamo.
Alcuni studi dicono che ciascuno di noi pronuncia 24.000 parole in un solo giorno. Il numero può cambiare, influenzato da diversi fattori. Ma ciò che non cambia è che le parole tessono la trama delle nostre relazioni sociali. Possono avvicinarci alle altre persone, creare ponti. Ma possono anche escludere, ferire, non far sentire le persone rappresentate, ascoltate, viste. E possono compromettere qualsiasi progetto; anche l’experience meglio strutturata può sgretolarsi se mancano la cura e l’attenzione nella scelta delle parole.
In questo articolo spieghiamo perché è importante che aziende e organizzazioni riflettano sull’utilizzo di un linguaggio ampio o inclusivo, concentrandoci sull’esperienza della design company logotel.
Cos’è il linguaggio inclusivo o ampio
La sensibilità verso un tipo di linguaggio che non escluda – chiamato linguaggio inclusivo o linguaggio ampio – nasce proprio dal bisogno che alcune persone avvertono. Una necessità legata al fatto di non sentirsi rappresentate da alcune convenzioni linguistiche – una su tutte, il maschile sovraesteso, cioè l’utilizzo del maschile per indicare gruppi misti o persone di genere non specificato – ben radicate nel nostro modo di scrivere e parlare.
Cos’è il linguaggio ampio o inclusivo? Per linguaggio inclusivo si intende quello libero da parole, frasi o toni che riflettono opinioni pregiudizievoli, stereotipate o discriminatorie verso determinati gruppi di persone. L’aggettivo inclusivo, però, presuppone sempre che vi sia qualcuno titolato a includere (o escludere) altre persone. È per questo motivo che, in molti casi, si preferisce utilizzare il termine linguaggio ampio.
Perché è importante usare un linguaggio ampio
Usare un linguaggio che non discrimini e sia scevro da pregiudizi e stereotipi è, in primo luogo, una questione di rispetto. Dovrebbe essere un’attenzione condivisa da tutte le persone, sul lavoro così come nella vita di tutti i giorni.
Ma diventa ancora più importante per chi progetta servizi, esperienze, soluzioni che si rivolgono a un pubblico eterogeneo e devono (o dovrebbero) tenere in conto i diversi bisogni che questo pubblico esprime.
In questo caso, il rischio che si corre è duplice: da un lato, discriminare, escludere, non rappresentare. Dall’altro, non essere efficaci in ciò che si fa. Perché usare un linguaggio non inclusivo presuppone in fondo un errore di progettazione: non essere stati in grado di vedere le molteplicità a cui ci si doveva rivolgere, e raccontare quindi una storia sola anziché tante storie, cadendo così nello “stereotipo della storia unica”, come afferma la scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie.
Ma come si traduce tutto questo nella pratica quotidiana di un’azienda? L’esperienza di logotel offre alcune risposte concrete.
Il case study logotel: una riflessione sul linguaggio per valorizzare le molteplicità
Proprio la valorizzazione delle molteplicità è uno dei driver che spingono l’Independent design company logotel a interrogarsi costantemente sull’evoluzione del linguaggio e su come utilizzarlo per creare uno spazio comunicativo rispettoso e aperto, nel quale poter collaborare.
Dal 1993 la design company è impegnata a generare impatti positivi attraverso un metodo chiamato Impact design e utilizzando un approccio che mette al centro della propria progettualità le persone e le comunità (People & community centred approach).
Logotel offre ai propri clienti diversi servizi: dalla progettazione di servizi ed esperienze fisico-digitali ai percorsi di formazione e change management, fino alle digital business community. Queste ultime sono ambienti digitali che, attraverso team dedicati, palinsesti di contenuti e iniziative, servizi e attività, motivano e coinvolgono le persone, all’interno o all’esterno di un’organizzazione.
Il linguaggio è parte integrante di tutte le progettualità ed è da questa consapevolezza – oltre che da una sensibilità ben radicata nei valori che accompagnano logotel fin dalla sua fondazione – che nascono le riflessioni sul linguaggio ampio e in generale le iniziative in ambito DEI che l’azienda porta avanti ogni giorno.
Tra questi progetti figurano percorsi di sensibilizzazione sviluppati assieme ai propri partner come Valore D – associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese. Vi sono poi progetti specifici in ambito DEI sviluppati con i clienti e anche corsi di formazione interna specifici sul linguaggio ampio, come quello tenuto da Luisella Peroni, Senior Lead Community & DEI Expert e docente di business writing.
La responsabilità di chi lavora con le parole
“Chi lavora con le parole, come facciamo noi, ha una responsabilità in più. Deve sempre chiedersi: cosa escludiamo dal nostro campo visivo? In logotel ci definiamo tutti un po’ designer, e nel design si parte sempre dai bisogni delle persone e delle comunità per cui si progettano servizi, esperienze, soluzioni”, spiega Luisella.
“Viviamo in società molteplici, che necessitano di narrazioni plurali per evitare di cadere e perpetuare anche nel linguaggio discriminazioni sistemiche quali razzismo, classismo, ageismo, discriminazioni di genere e omotransfobia. Per questo motivo dobbiamo cercare parole precise che evitino generalizzazioni e non dividano”.
Il corso di formazione linguaggio ampio, destinato alle persone di logotel, non è un insieme di regole né un elenco di termini giusti e altri da mettere al bando. Si tratta piuttosto di un invito ad aprirsi a nuove sensibilità, di uno stimolo a riflettere insieme sugli orizzonti della nostra lingua partendo da due assunti:
- che “la lingua non è un museo”, come afferma tra le altre la sociolinguista Vera Gheno, che è stata ospite di logotel per un talk interno;
- che il linguaggio ampio o inclusivo non è una gabbia per dire meno – quel “non si può più dire niente” che i critici utilizzano in maniera pretestuosa per stroncare sul nascere qualsiasi discussione sul tema –, ma al contrario uno stimolo creativo per cercare nuovi modi per dire molto di più.
Il corso è strutturato in più parti. La prima è una panoramica sul contesto frammentato e polarizzato del dibattito sui temi legati alla diversity, equity e inclusion applicati al linguaggio.
La parte centrale è dedicata al cambio di mindset e alla nuova prospettiva che servono per inquadrare la questione ponendo il focus non più sul concetto di diversity, ma su quello di molteplicità, e cioè l’unione di più unicità. “Diversità presuppone l’esistenza di una normalità – spiega Luisella Peroni –. Unicità, invece, presuppone una pluralità naturale.”
La parte finale del corso è dedicata a imparare a riconoscere i pregiudizi su cui si fonda spesso il nostro linguaggio e a sperimentare modalità pratiche per sostituirli con un nuovo pensiero e, quindi, nuove parole.
Ad esempio: utilizzare perifrasi (scrivere “chi si candida” anziché “il candidato”), usare la doppia formula (“ragazze e ragazzi”), inserire una nota iniziale metodologica per spiegare la ratio utilizzata nella scrittura di un testo. O, ancora, utilizzare grafismi come la schwa (citata nell’introduzione), che per questo articolo si è scelto di non usare perché presenta problemi di accessibilità per screen reader e persone con dislessia.
In conclusione: le parole sono importanti!
Quanto aziende come logotel portano avanti sul tema del linguaggio ampio è una best practice che risponde alle esigenze di una società e di un mondo del lavoro in trasformazione.
Ma affinché queste iniziative possano resistere a venti contrari, backlash e pressioni politiche, devono affondare le proprie radici in una solida visione aziendale basata su valori condivisi. È su quel terreno che percorsi di formazione e consulenza dedicati, come quelli presentati in questo articolo, possono dare frutti.
“Le parole sono importanti”, urlava Nanni Moretti in uno dei suoi film più iconici, Palombella Rossa. E aveva ragione: usarle per creare ponti anziché barriere è una scelta che fa la differenza ogni giorno.
Ma c’è anche una ragione più profonda per cui vale la pena investire sul linguaggio. Come sosteneva Ludwig Wittgenstein, i limiti del linguaggio di una persona sono i limiti del suo mondo.
Ampliare il linguaggio significa quindi ampliare la propria mente, allargare i confini di ciò che possiamo immaginare e costruire insieme. Un esercizio di cui c’è sempre più bisogno per un mondo che sia veramente plurale e rispettoso.