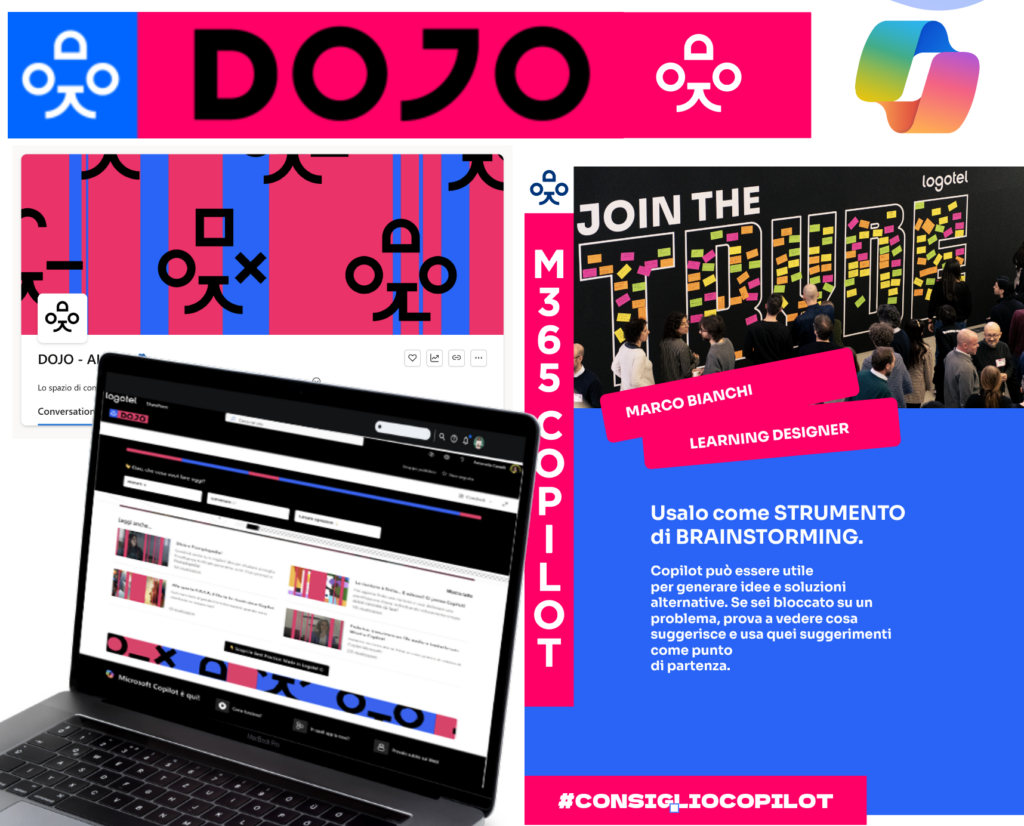A dieci anni dall’Accordo di Parigi sul clima, il clima sulla sostenibilità è cambiato.
Pressioni politiche, cause legali e un’ondata di opposizione alle politiche progressiste di inclusione e sostenibilità, etichettate dai critici come “woke”, hanno trasformato iniziative ESG (Environmental, social, governance) e DEI (Diversity, equity, inclusion) – un tempo celebrate – in fonti di controversia.
Questo sentiment negativo non riguarda solo gli Stati Uniti guidati da Donald Trump. Secondo il sondaggio Sustainability at a Crossroads del luglio 2025, il 71% degli esperti europei di sostenibilità riporta un forte contraccolpo (backlash) contro gli sforzi aziendali per la sostenibilità.
Persino leader che si sono sempre espressi apertamente su questi temi, come Bill Gates, hanno modificato la propria strategia comunicativa, come evidenziato dal recente articolo – in parte travisato – del fondatore di Microsoft sulle “tre dure verità sul clima”.
Ma davvero le lotte al cambiamento climatico e, più in generale, a favore della diversity, equity e inclusion, vivono o sono destinate a vivere una battuta d’arresto? In realtà, non è così.
Sebbene molti leader aziendali riconoscano la necessità di cambiare le modalità in cui si portano avanti le iniziative legate alla sostenibilità, queste ultime non si stanno bloccando, anzi: vanno avanti, ma in alcuni casi lo fanno in silenzio.
È il quiet corporate activism, cioè l’attivismo silenzioso, una modalità di corporate social responsibility emergente, fotografata tra gli altri da un articolo apparso sulla MIT Sloan Management Review.
In questo articolo spieghiamo cosa significa, analizziamo quali sono alcune strategie concrete per portarlo avanti e riportiamo anche le critiche a questo modo silenzioso di fare CSR.
Dalla COP21 alla COP30: cosa è cambiato
Nel 2015, la COP21 (Conferenza delle parti) di Parigi segnò un punto di svolta per le politiche sulla lotta al cambiamento climatico. In quella sede vennero definiti tra gli altri l’obiettivo per gli Stati di limitare il riscaldamento globale tra 2 e 1,5 gradi centigradi e l’obiettivo di raggiungere progressivamente la neutralità climatica, il Net zero.
A dieci anni da quell’accordo, la COP 30 di Belém, nel cuore dell’Amazzonia, si svolge in contesto internazionale tutt’altro che favorevole.
Intanto, gli USA sono usciti – per la seconda volta, e sempre su spinta di Trump – dall’Accordo di Parigi. In secondo luogo, come sottolinea tra gli altri l’ISPI (Istituto di studi politici internazionali), tra deforestazione, tensioni geopolitiche e scetticismo crescente, le speranze di nuovi accordi ambiziosi sono flebili. Anche perché gli stessi Stati Uniti, un Paese che influisce molto sulle emissioni globali, non partecipano alla conferenza.
In questo contesto, è inevitabile che vi siano stati contraccolpi anche sulle aziende.
Julia Binder e Heather Cairns-Lee, le due professoresse dell’Institute for Management Development (IMD) autrici dell’articolo sul quiet corporate activism, sottolineano che alcune aziende europee come Novartis, Roche, SAP e UBS hanno ridimensionato i programmi legati al tema diversity.
E anche prima dell’ultima ondata anti-woke legata alla rielezione di Trump, le autrici scrivono che molte aziende avevano subito pressioni da parte di azionisti conservatori per abbandonare le iniziative su DEI e clima. Queste pressioni, in alcuni casi, hanno portato anche a licenziamenti e cause legali.
Sostenibilità e DEI continuano a essere priorità per molte aziende
Tuttavia, né la sostenibilità aziendale né la DEI sono morte, come invece recitano i titoli di diversi articoli apparsi negli ultimi anni.
Secondo il KPMG Ceo outlook 2025 – autorevole survey che coinvolge 1.350 amministratori delegati -, ad esempio, la maggior parte dei leader aziendali rimane fortemente impegnata rispetto ai propri obiettivi di sostenibilità e si mostra sempre più fiduciosa nel raggiungerli. Il 61% degli intervistati afferma di essere sulla buona strada per raggiungere i propri obiettivi net zero entro il 2030, in crescita rispetto al 51% dell’anno prima.
Un recente articolo di Forbes riporta invece i risultati di uno studio del 2025 di Resume.org, secondo cui l’87% delle aziende sta mantenendo invariati o addirittura aumentando i propri budget per le iniziative in ambito DEI.
E infine, per quanto riguarda l’Italia, una recente ricerca di iSustainability rivela che ben due imprese su tre prevedono un calo di competitività in assenza di una corretta integrazione della sostenibilità nei loro modelli di business.
Sono tutti segnali che evidenziano come vi siano aziende disposte a difendere – anche “ad alta voce” – i propri valori. Come, ad esempio, l’Independent design company logotel, che diventando società benefit nel 2024 ha integrato nel proprio statuto, oltre al conseguimento del profitto economico, anche quattro finalità di beneficio comune per operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente.
Cos’è il quiet corporate activism: dal greenwashing al greenhushing
Tra i due poli opposti – chi fa marcia indietro e chi prosegue a testa alta con i propri sforzi in ambito ESG e DEI – si situa il quiet corporate activism.
Le autrici lo definiscono come “una forma di gestione del rischio che consente il progresso a lungo termine”. Un nuovo equilibrio che i leader devono trovare tra i proclami, che possono attirare critiche e attenzioni sgradite, e le azioni e politiche concrete da continuare ad attuare silenziosamente tra le mura aziendali.
Il quiet corporate activism riflette un cambio di strategia che alcuni leader aziendali potrebbero attuare in presenza di contesti politici e normativi ostili alle loro agende ambientali e sociali.
L’attivista Bill Moyer ha identificato quattro ruoli distinti che gli individui possono svolgere per far avanzare il cambiamento sociale: cittadino, ribelle, agente di cambiamento e riformatore.
Rifacendosi al suo lavoro, le autrici suggeriscono che in tempi in cui la struttura di potere dominante si oppone alla loro agenda, i leader aziendali potrebbero aver bisogno di passare dal ruolo di ribelle – cioè qualcuno che assume una posizione di rilievo contro l’ingiustizia – a quello di agenti di cambiamento e riformatori.
Gli agenti di cambiamento lavorano dietro le quinte – in silenzio – per educare e organizzare il cambiamento, mentre i riformatori cercano di istituzionalizzare quei cambiamenti all’interno di sistemi stabiliti, attraverso policy e struttura aziendali.
Per fare un esempio concreto, un’azienda che si impegna nell’attivismo silenzioso potrebbe implementare al proprio interno politiche progressiste – assunzioni inclusive, riduzioni delle emissioni inquinanti o investimenti nella comunità – senza comunicarle, confidando che a parlare siano gli effettivi impatti.
In questa maniera le aziende continueranno a lavorare verso obiettivi ESG e DEI, ma senza comunicarlo all’esterno. Un fenomeno definito greenhushing. Il termine, che si può tradurre in italiano come silenzio verde o eco-silenzio, non è del tutto nuovo e presenta molte accezioni negative, come vedremo in seguito. Tuttavia, secondo le autrici dell’articolo, nel contesto attuale può essere una strategia difensiva per le aziende che rimangono impegnate nella sostenibilità ma vogliono evitare contraccolpi.
Cinque strategie per portare avanti il quiet corporate activism
Come portare avanti, nel concreto, il quiet corporate activism? L’articolo suggerisce cinque strategie.
Scegliere le battaglie strategicamente
I leader più efficaci distinguono tra questioni su cui possono ancora essere portavoce pubblici e quelle in cui esporsi potrebbe ritorcersi contro, danneggiando la causa stessa. L’approccio consiste nel concentrare gli sforzi visibili sulle tematiche più rilevanti per il business e più allineate con i valori aziendali, proteggendo così la propria credibilità senza esaurire il capitale politico dell’organizzazione.
Riformulare senza ritirarsi
Cambiare il linguaggio usato, evitando termini politicamente polarizzanti, è una delle strategie più semplici ma efficaci. Non si tratta di ingannare, ma di trovare un vocabolario che si concentri su valori condivisi e che diversi pubblici possano accogliere positivamente.
L’esempio più significativo, citato dalle due professoresse autrici dell’articolo è quello di Costco, la seconda catena di supermercati più grande al mondo dopo Walmart. Mentre numerosi rivenditori americani stavano abbandonando o ridimensionando le iniziative DEI sotto pressione nel 2024, il consiglio di amministrazione di Costco ha scelto di mantenerle, ma cambiando strategia comunicativa.
E così, il dipartimento “Diversity and Inclusion” è stato rinominato “People and Communities”, mentre nella comunicazione agli azionisti l’azienda ha enfatizzato principi universali (“Accogliamo membri di ogni estrazione sociale e background”) e vantaggi di business concreti (una forza lavoro diversificata “aiuta a portare originalità e creatività” nel servire i clienti), evitando parole d’ordine controverse. Il risultato: gli azionisti hanno sostenuto a larga maggioranza la decisione di mantenere i programmi.
Costruire supporto all’interno dell’organizzazione
Per sostenere gli impegni sociali quando il contesto esterno è ostile, è fondamentale creare un forte allineamento all’interno. Questo significa coinvolgere dipendenti, management e partner attorno ai valori dell’organizzazione, assicurandosi che l’impegno non si eroda solo perché è diventato meno visibile all’esterno.
I dati dimostrano quanto questo sia strategico: secondo alcune ricerche citate nell’articolo della MIT Sloan Management review, l’87% della Generazione Z e dei Millennial lascerebbe il proprio lavoro per uno più allineato con i propri valori. Una forza lavoro che crede in una mission la porterà avanti anche quando la comunicazione pubblica deve essere più discreta.
Sfruttare alleanze informali
Quando l’advocacy pubblica diventa rischiosa, il potere si sposta spesso in reti meno visibili. Alleanze informali – comunità di apprendimento tra pari, gruppi industriali confidenziali, coalizioni discrete – permettono alle aziende di condividere best practice, coordinare risposte alle pressioni politiche e rafforzare collettivamente la propria determinazione.
Un esempio è quello dell’IMD (International Institute for Management Development), che convoca gruppi di Chief sustainability officer operanti sotto la Chatham House Rule: i partecipanti possono usare le informazioni ricevute ma non rivelare le fonti né le identità degli altri membri. In questo ambiente protetto, i dirigenti condividono apertamente strategie reali, successi e fallimenti, accelerando l’apprendimento reciproco senza rischi reputazionali.
Incorporare i valori nelle operazioni
La forma più potente di attivismo silenzioso si realizza quando un’azienda integra così profondamente i propri valori sociali e ambientali nelle operazioni quotidiane che non ha più bisogno di iniziative speciali. Il purpose diventa così radicato da non attirare più attenzione, eppure continua a plasmare costantemente i risultati.
L’esempio paradigmatico è IBM, che ha avviato un programma di diversità dei fornitori negli anni ’60, molto prima che diventasse una pratica diffusa. Oggi questo programma è diventato “il modo in cui IBM fa business” – una pratica strutturale che ha fatto avanzare l’inclusione economica per decenni, indipendentemente dall’attenzione mediatica del momento.
Le critiche all’attivismo silenzioso
Il silenzio non è sempre d’oro, come recita il proverbio. In tempi di grande polarizzazione, è vero che per le aziende esporsi su tematiche ritenute sensibili può causare gravi contraccolpi, che possono addirittura minare la continuità aziendale.
Allo stesso tempo, però, il greenhushing legato al quiet corporate activism può essere visto come l’altra faccia della medaglia del greenwashing.
Mentre nel caso del greenwashing il problema è di “dire troppo”, nel senso di fare affermazioni roboanti che non corrispondono alla realtà e promesse che non si possono mantenere, nel caso del grenhushing il problema è dire “troppo poco” o niente.
Già in passato erano apparsi diversi articoli e report critici contro il greenhushing. Il report On the road to net zero 2024 della società di consulenza svizzera South Pole, la prima a menzionare il greenhushing, evidenzia che tutti i settori industriali sono coinvolti dal fenomeno. Secondo Nadia Kähkönen, direttrice delle comunicazioni di South Pole, “evitando di intraprendere passi imperfetti per il timore di essere criticati, non ci sarà alcun passo avanti”.
Il silenzio può essere interpretato come scarsa trasparenza, opportunismo, codardia. E i rischi sono molteplici, come spiegano le stesse autrici dell’articolo apparso sulla MIT sloan management review: dalla perdita di fiducia pubblica se gli stakeholder pensano che i leader aziendali abbiano rinunciato a determinati valori, a dipendenti sempre più demoralizzati, che non si riconoscono in una leadership poco audace. Senza contare il problema di fondo: rimanere in silenzio rispetto a problemi percepiti come ingiustizie è etico o è invece da ignavi?
In conclusione
Su temi come sostenibilità e DEI non esiste una formula universale che funzioni per tutte le organizzazioni.
Per le aziende che credono nell’importanza di creare valore condiviso e ambienti di lavoro più equi e sostenibili, la domanda non è se continuare, ma come farlo nel modo più efficace e sostenibile nel lungo periodo. Il punto di equilibrio tra comunicare pubblicamente le proprie iniziative e agire in maniera più discreta, portando avanti un quiet corporate activism, dipende dal settore, dalla geografia, dalla cultura aziendale e dalle aspettative degli stakeholder.
L’essenziale, in definitiva, è mantenere il focus sulla sostanza piuttosto che sulla forma. Ciò che conta è che l’impegno per la sostenibilità, l’equità e l’inclusione continui a tradursi in azioni concrete, politiche strutturali e cambiamenti misurabili.