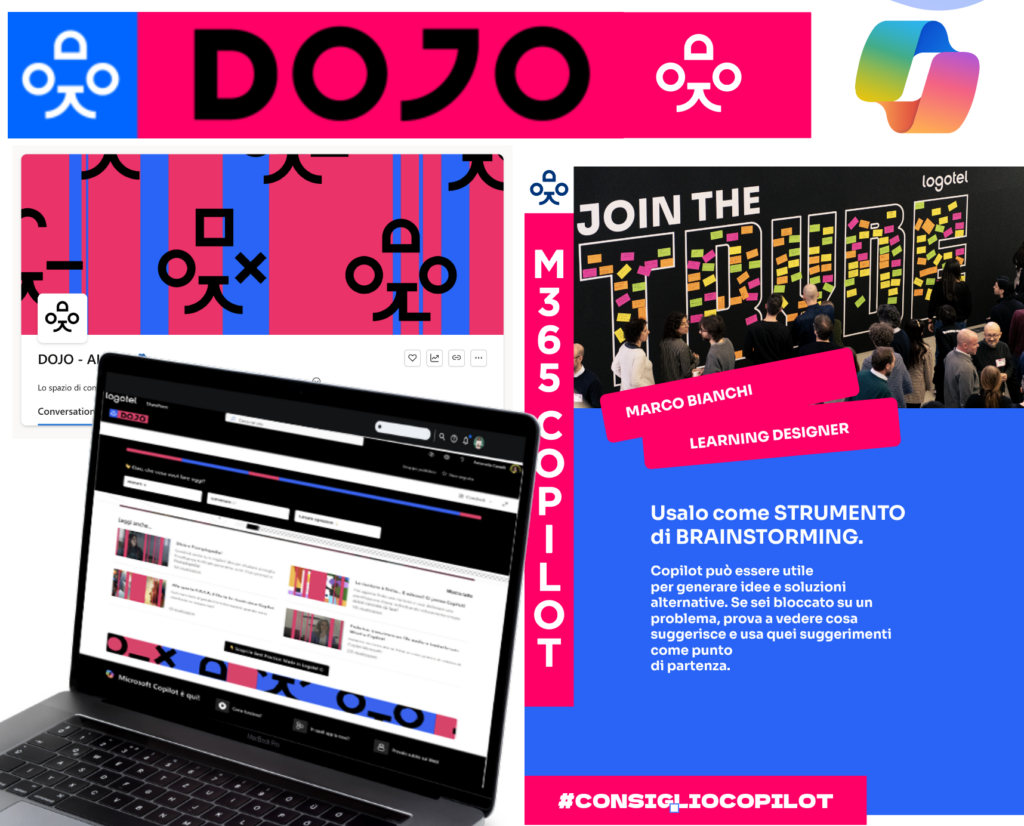Quando si parla di benessere sul lavoro, spesso si pensa a benefit, orari flessibili, programmi di welfare. Tutti aspetti importanti, certo. Ma oggi, c’è un altro elemento che si sta rivelando determinante per far stare bene le persone (wellbeing) e, di conseguenza, farle restare in azienda (retention): la sicurezza psicologica.
Non è una buzzword e non riguarda solo le aziende “illuminate”. È un concetto sempre più centrale per comprendere il funzionamento dei team, la qualità del lavoro quotidiano, la capacità di apprendere e di innovare, e in ultima analisi, la tenuta delle organizzazioni in tempi incerti.
Sono diverse le evidenze recenti che sottolineano l’importanza della sicurezza psicologica specialmente in un contesto di grande trasformazione e incertezza come quello attuale.
Google, ad esempio, nell’ambito del suo progetto di ricerca Aristotle, ha identificato proprio la psychological safety come la condizione numero uno per un team efficace. Non la competenza tecnica, né il mix di personalità o il carisma del manager. Ma la possibilità, per ciascun membro, di sentirsi al sicuro nel prendere parola, fare domande, avanzare dubbi, proporre idee, anche sbagliate, senza temere umiliazioni o ritorsioni.
Cos’è la sicurezza psicologica (e cosa non è)
Amy Edmondson, professoressa alla Harvard Business School e pioniera del concetto di sicurezza psicologica, definisce la psychological safety come la convinzione condivisa che il team sia un luogo sicuro per l’interazione personale e professionale. Significa poter essere sé stessi, esporsi, rischiare l’errore o la divergenza di opinione, senza che questo venga punito o svalutato.
Attenzione però: sicurezza psicologica non significa “tolleranza assoluta” o “assenza di conflitto”. Al contrario, è ciò che consente ai team di affrontare conflitti in modo sano, mettere in discussione le idee e prendere decisioni migliori. Non è sinonimo di comfort, ma di fiducia reciproca.
Quando c’è sicurezza psicologica, anzi, si è invogliati a uscire dalla propria zona di comfort: a provare, a sperimentare. A essere quelli che l’Independent design company logotel definisce tryler: persone che si muovono, che sperimentano nuove pratiche e nuovi modi di fare le cose per anticipare il futuro e generare impatto.
Senza sicurezza psicologica, al contrario, i team tendono a irrigidirsi. Le persone evitano di parlare per paura di sbagliare, si autocensurano, non fanno domande nemmeno quando non capiscono, non segnalano problemi finché non esplodono. L’apparenza di armonia nasconde un progressivo rallentamento della collaborazione e dell’apprendimento.
Come capire quando la sicurezza psicologica manca (e quando c’è)
Come capire se un team lavora in un clima di sicurezza psicologica? I segnali sono spesso sottili ma riconoscibili. Nei team dove manca, le persone fanno domande solo ai colleghi più vicini, intervengono poco nelle riunioni, non chiedono feedback o, quando lo fanno, preferiscono riceverlo in privato. Nei casi più estremi, si diffondono frasi come “non vale la pena parlare”, “tanto non cambierà nulla”, “meglio non esporsi”.
Al contrario, in un team psicologicamente sicuro, si osservano dinamiche molto diverse. Le persone si correggono a vicenda, chiedono chiarimenti, condividono errori senza paura. Le idee vengono discusse apertamente, anche quando non sono popolari. I feedback sono frequenti, bidirezionali, a volte informali. In questi contesti, il tasso di innovazione e di apprendimento tende a salire.
Sicurezza psicologica sul lavoro e retention: un legame sempre più forte
In un momento storico in cui le aziende fanno fatica a trattenere i talenti – soprattutto tra le generazioni più giovani – la sicurezza psicologica si rivela una leva decisiva. Non è solo una questione etica o culturale: è anche una scelta strategica.
Uno studio pubblicato sull’International Journal of Public Health e citato in un recente articolo dell’Harvard Business Review ha evidenziato come i lavoratori che percepiscono alti livelli di sicurezza psicologica siano significativamente meno inclini a cambiare lavoro. Anche se lo studio riguarda l’ambito medico, i suoi autori sostengono che le evidenze si possano applicare a tutti i settori lavorativi.
Le persone che si sentono psicologicamente al sicuro tendono a restare nella propria azienda non perché sia “perfetta”, ma perché sentono di avere uno spazio di espressione, ascolto e crescita.
A questo si aggiungono i dati qualitativi raccolti in numerose indagini sul clima interno: dove la sicurezza psicologica è alta, le persone riportano maggiore soddisfazione lavorativa, minore stress, un più forte senso di appartenenza e un maggiore impegno nei confronti dell’organizzazione.
Come si costruisce (davvero) un ambiente sicuro
Costruire sicurezza psicologica non si fa con una policy o con una campagna di comunicazione interna. Richiede comportamenti coerenti, quotidiani, visibili. E riguarda tanto i leader quanto i colleghi.
I manager, certo, giocano un ruolo cruciale: possono normalizzare l’errore, fare domande aperte, riconoscere i contributi altrui, ringraziare chi ha il coraggio di esprimere un dissenso.
Pensiamo ad esempio a un altro studio sulla correlazione tra benessere psicologico e retention nel contesto di studi professionali: Safe to stay: The role of leader behaviors and psychological safety in employee retention in high-demand workplaces. Tra i dipendenti presi in esame, quelli che manifestavano maggiore attaccamento alla propria azienda hanno raccontato storie di leader con elevata intelligenza emotiva, capaci di incoraggiare l’autenticità sul posto di lavoro e di promuovere il commitment affettivo verso l’organizzazione.
Anche i membri del team possono tuttavia contribuire attivamente alla costruzione di sicurezza psicologica: ascoltando con curiosità, non interrompendo, ammettendo di non sapere, chiedendo feedback.
Un buon punto di partenza è fare domande come: “Cosa potrei fare di diverso per aiutarti a esprimerti di più?” oppure “Cosa ti ha fatto sentire incluso, o escluso, in questa riunione?”. È anche importante accogliere i feedback ricevuti senza difendersi, anche quando toccano corde scomode.
A tal proposito, è illuminante quanto condiviso da Adam Grant, psicologo delle organizzazioni alla Wharton School dell’Università della Pennsylvania, dal palco del WOBI – World business forum 2025 di Milano.
Per sbloccare il potenziale nascosto proprio e delle persone del proprio team Grant ha invitato tutto il pubblico, oltre che a creare sicurezza psicologica, anche a circondarsi di quella che ha definito un challenge network – una rete che supporti, ma anche che metta in dubbio il lavoro che si svolge – e trasformare le critiche in consigli.
Perché oggi la sicurezza psicologica è più urgente che mai
L’attenzione alla sicurezza psicologica non nasce oggi, ma il contesto attuale ne rende l’urgenza ancora più evidente. L’adozione massiva dell’intelligenza artificiale nei processi lavorativi, l’aumento del lavoro ibrido, la frammentazione dei team e il senso diffuso di incertezza stanno mettendo a dura prova la coesione, la comunicazione e il senso di agency delle persone.
Non è un caso se, in tutto il mondo, i disturbi del cervello stanno aumentando a ritmo vertiginoso, e se anche il World economic forum spinga verso un nuovo paradigma che metta al centro dello sviluppo di aziende e Paesi il brain capital, un asset economico che integra salute del cervello e competenze cerebrali.
In questo scenario, la sicurezza psicologica è il fondamento per qualsiasi cambiamento sostenibile: “La sicurezza psicologica è fondamentale per prevenire il burnout e il turnover del personale nei periodi di turbolenza”, scrive l’autore dell’articolo In Tough Times, Psychological Safety Is a Requirement, Not a Luxury pubblicato sull’HBR.
Senza un clima in cui si può parlare apertamente, diventa difficile adottare nuove tecnologie, migliorare i processi, riorganizzare i ruoli, cambiare cultura. Al contrario, un contesto sicuro facilita il dialogo, l’adattamento, la partecipazione attiva.
Per questo sempre più organizzazioni la mettono al centro dei programmi di leadership, delle iniziative di wellbeing, dei percorsi di sviluppo. Non come una moda, ma come una condizione abilitante per tutto il resto.
La sicurezza psicologica non si misura in KPI, ma si riflette nei gesti quotidiani, nella qualità delle conversazioni, nel modo in cui si affrontano i conflitti, si ammettono gli errori, si prendono le decisioni.
Ed è da lì che passa il benessere, la retention, e la capacità di un’organizzazione di restare viva, reattiva e umana, anche in un contesto che cambia sempre più in fretta.