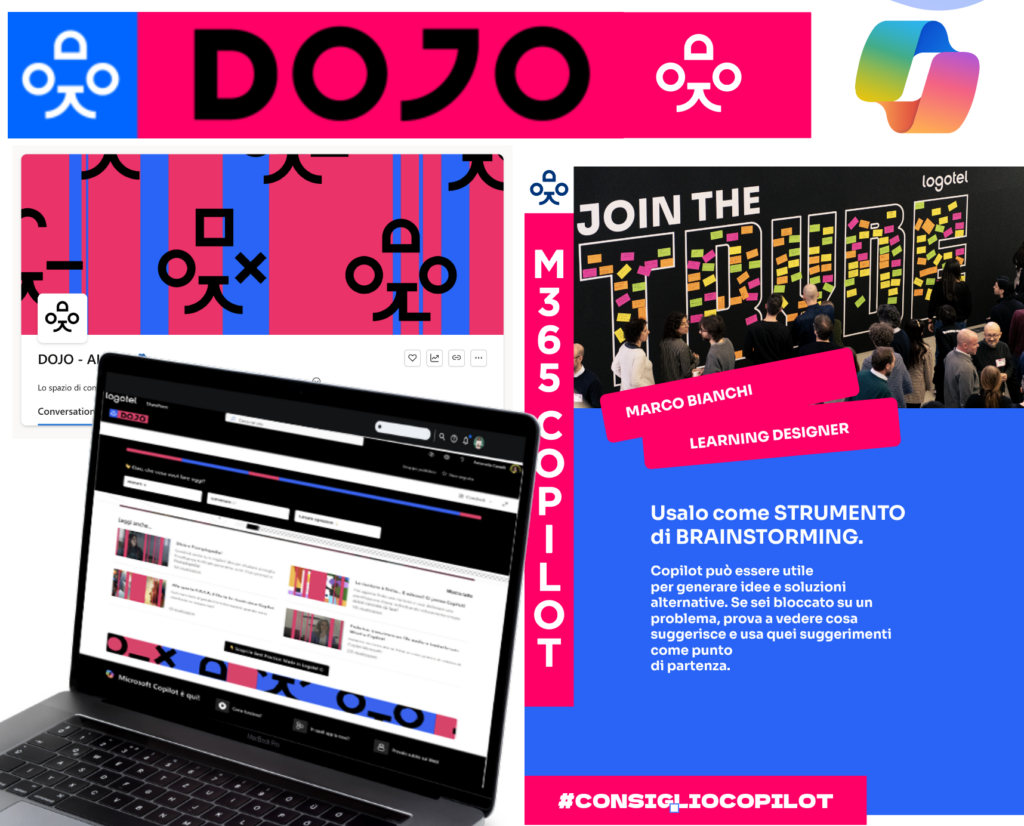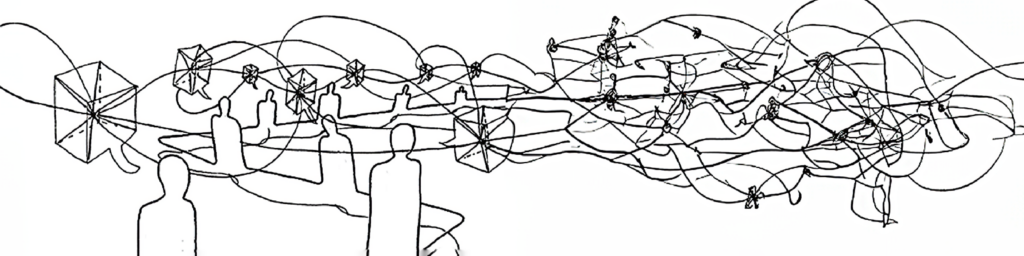Il passaggio da brain health a brain capital
“Ogni decisione, innovazione e atto di leadership nasce nel cervello umano”. Con queste poche, potenti parole, la professoressa Monica Diluca ha aperto il suo intervento al World business forum 2025 di Milano organizzato da WOBI.
L’evento – al quale ha partecipato anche la Independent design company logotel – riunisce ogni anno migliaia di leader aziendali e manager che discutono i temi più rilevanti nel campo del management e del business, lasciandosi ispirare da esperti provenienti da mondi diversi: business, sport, spettacolo e scienza.
Diluca, docente di farmacologia e prorettrice alla ricerca all’Università degli Studi di Milano, ha ricordato a tutti i leader e manager presenti all’evento che è la salute del cervello che rende possibile ogni altra forma di benessere ed è da un cervello in salute che dipendono, in ultima analisi, produttività e progresso.
Il concetto di base espresso dalla professoressa, che dal 2026 sarà la prima donna alla guida della Società italiana di farmacologia e ha dedicato la sua lunga carriera alla ricerca sulle malattie neurodegenerative, è che la salute del cervello non deve essere vista solo come un valore in ambito medico, ma come un valore economico per la società intera e le aziende e organizzazioni che ne fanno parte.
È il passaggio da brain health a brain capital, un cambio di paradigma che si sta affacciando negli ultimi anni in autorevoli consessi internazionali come l’Organizzazione delle nazioni unite, il World economic forum, l’Euro-Mediterranean Economists Association.
In questo articolo, partendo dalla diffusione e dai costi – economici e sociali – dei disturbi al cervello, spieghiamo cos’è il brain capital e perché aziende e organizzazioni dovrebbero investire nella salute del cervello e sviluppare brain capital.
Quanto sono diffusi i disturbi al cervello e quanto costano
Viviamo in un’epoca che non è affatto brain-friendly. Pensiamo solo ad alcuni fenomeni con cui, soprattutto i cosiddetti lavoratori della conoscenza, hanno a che fare quasi quotidianamente.
In primo luogo, siamo sommersi da informazioni e dati. Il sovraccarico informativo è stato negli ultimi anni ulteriormente accentuato dall’esplosione dell’intelligenza artificiale generativa. Pensiamo solo al fenomeno dell’AI slop, anche in ambito lavorativo (workslop): si moltiplicano i contenuti che dobbiamo vagliare e di conseguenza aumentano gli sforzi cognitivi per capire se si tratta di informazioni rilevanti o no, e diminuisce la nostra soglia di attenzione.
Un altro fenomeno che riguarda soprattutto i Paesi più sviluppati è la carenza di sonno. Secondo il neuroscienziato dell’Università della California Berkeley Matthew Walker, autore del libro Perché dormiamo, Poteri e segreti del sonno per una vita sana e felice, due terzi degli adulti che vivono nei Paesi più sviluppati non raggiungono le otto ore di sonno notturno consigliate dall’OMS per essere in buona salute.
Lo stile di vita e lavorativo ci espone inoltre a stress e al rischio burnout. Secondo l’articolo The Burnout Age: Real Pain Requires Real Solutions apparso sulla MIT Sloan Management Review, oltre un cittadino statunitense su due ha sperimentato questa forma di disturbo, che Christina Maslach, ricercatrice e docente presso l’Università della California, Berkeley, definisce così: “Una risposta psicologica derivante da stress cronico sul posto di lavoro che si manifesta attraverso tre sintomi principali: sensazione di esaurimento, cinismo e distacco, e percezione di mancanza di soddisfazione”.
I numeri che riguardano le malattie o i disturbi del cervello sono impressionanti. In Europa ne sono affetti circa 179 milioni di cittadini. E in Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania e 12 milioni di cittadini lamentano disturbi del sonno.
L’ampia diffusione di questi disturbi comporta sia costi diretti, legati alla cure mediche e all’assistenza, sia costi indiretti che si ripercuotono sulle famiglie e sulle aziende.
Secondo il World economic forum, i disturbi cerebrali hanno un costo per l’economia globale pari a 5 trilioni di dollari ogni anno, destinato ad aumentare fino a 16 trilioni di dollari nel 2030.
La sola carenza di sonno, secondo un rapporto della RAND corporation citato nel libro di Walker, impatta sul PIL (prodotto interno lordo) delle nazioni per oltre il 2 per cento.
“La mancanza di sonno deteriora molte delle abilità fondamentali richieste per la maggior parte delle professioni”, scrive Walker: creatività, intelligenza, motivazione, sforzo, efficienza, efficacia quando si lavora in gruppo, stabilità emotiva, socievolezza e onestà. Lo stesso avviene più in generale per gli altri disturbi del cervello.
Cos’è il brain capital
L’impatto dei disturbi del cervello sulla salute individuale e sull’economia e la società nel loro complesso sta alimentando da anni una nuova consapevolezza: e cioè che la salute del cervello è un investimento strategico per le aziende, i Paesi e per la società.
E questa consapevolezza sta spingendo verso un nuovo paradigma, che si focalizza sul passaggio dal concetto di brain health (salute del cervello), a quello di brain capital (capitale cerebrale).
Per brain health si intende più del concetto di salute (e benessere) mentale, un tema che a partire dalla pandemia di Covid ha guadagnato maggiore spazio all’interno dei piani di welfare delle aziende.
La salute del cervello, secondo quanto ha condiviso la professoressa Diluca, “è uno stato permanente in cui ogni individuo può realizzare le proprie capacità e potenzialità, ottimizzare il proprio funzionamento mentale, cognitivo, emotivo, psicologico, comportamentale e motorio per far fronte alle situazioni della vita. E poter dare un contributo alla comunità”.
Cosa si intende, invece, per brain capital? Secondo un paper pubblicato sulla rivista scientifica Malaysian Journal of Medical Sciences da un team internazionale guidato dalla Brain Capital Alliance, il brain capital è “un asset economico che integra salute del cervello e competenze cerebrali, le risorse cerebrali cognitive sociali, emotive e diversificate di individui e comunità”.
Il brain capital opera su due livelli: da un lato è la conoscenza, le competenze creative e la salute cerebrale ottimale che ogni persona accumula nel corso della propria vita, consentendole di realizzare il proprio potenziale come membro produttivo della società. Dall’altro è il prodotto economico derivante da una salute cerebrale positiva collettiva, come scrive il WEF in un articolo.
Sul capitale cerebrale o cognitivo si fonda la brain economy, cioè un sistema economico la cui crescita e stabilità sono guidate dalla potenza cerebrale collettiva contribuita da comunità, società e Paesi. Un paradigma che, secondo chi lo propone, è più adeguato e rilevante per una società e un’economia moderne come le nostre, basate sull’informazione.
Perché aziende e organizzazioni devono investire nella salute del cervello
Ad oggi, come evidenziato dai numeri sulla diffusione e sul costo dei disturbi cerebrali, l’economia globale ha un impatto cerebrale moderato. Anzi, secondo un recente paper pubblicato su Brain Communications siamo in un’economia brain-negative (dannosa per il cervello), che erode il brain capital.
L’aumento del brain capital è vitale non solo a livello individuale, per il conseguimento di obiettivi educativi, l’aggiornamento e la riqualificazione delle competenze. Serve anche per passare a un’economia brain-positive, che secondo gli autori dello studio è la precondizione per agevolare le principali transizioni economiche globali ad alta intensità di competenze, come le transizioni verde e digitale.
Il brain capital è un asset economico critico per il successo delle economie del futuro. E le aziende che investono nella salute del cervello – come ha sottolineato la professoressa Diluca al WOBI – stanno costruendo le fondamenta del proprio brain capital e ponendo le basi per aumentare creatività, resilienza e performance.
Come aumentare il brain capital
Ma come fare per alimentare il brain capital? La professoressa Diluca nel suo intervento ha indicato cinque azioni prioritarie per dare valore al capitale cognitivo:
- investire su programmi di benessere neurocognitivo;
- creare ambienti di lavoro che riducano il rumore mentale;
- investire nella formazione;
- promuovere ambienti che incoraggiano relazioni di supporto, gestione consapevole dello stress, apprendimento continuo
- promuovere la consapevolezza della prevenzione per le malattie del cervello.
L’articolo su Brain communications sottolinea l’importanza di un approccio olistico, e presenta una roadmap dettagliata che riguarda anche i luoghi di lavoro, suddividendo le azioni tra breve e lungo termine.
Tra le prime, da attuare nel giro di 5 anni, rientrano ad esempio:
- sviluppare programmi di formazione sul luogo di lavoro e incoraggiare l’apprendimento continuo per sostenere lo sviluppo delle competenze cognitive e l’adattamento ai nuovi requisiti lavorativi;
- implementare programmi o framework per migliorare la salute del cervello, inclusa la promozione di un sano equilibrio tra vita e lavoro, la fornitura di risorse per la salute mentale (come ad esempio, giornate dedicate alla salute mentale) e il monitoraggio del carico di lavoro e dei livelli di stress.
Tra le azioni a lungo termine figurano:
- incorporare la salute del cervello nei framework ESG e fornire incentivi fiscali e sovvenzioni per le aziende e le organizzazioni che implementano programmi e politiche per la salute del cervello;
- creare percorsi per lo sviluppo professionale continuo che si concentrino sulle competenze cognitive, sull’intelligenza emotiva e sull’adattabilità per sostenere l’apprendimento permanente e l’avanzamento di carriera.
Un ecosistema per la salute del cervello, infrastruttura della prosperità collettiva
Dai punti sopra elencati è evidente che le aziende, da sole, possono avere un impatto limitato. Come ha sottolineato la professoressa Diluca nella parte conclusiva del suo speech, c’è bisogno di un “ecosistema per la salute del cervello”. Un’alleanza tra attori pubblici, privati e filantropici, come avviene per altre transizioni, come quella green, potrebbe produrre benefici duraturi e più sostanziali anche per agevolare la transizione a una brain-positive economy.
Resta, in ogni caso, il valore della riflessione condivisa dalla scienziata al WOBI: “Investire nel cervello è investire nel motore stesso della civiltà moderna, perché il cervello è la nuova infrastruttura della prosperità collettiva”. Una riflessione da cui tutti i leader aziendali dovrebbero partire per capire come investire in modo strategico e misurabile nel brain capital.