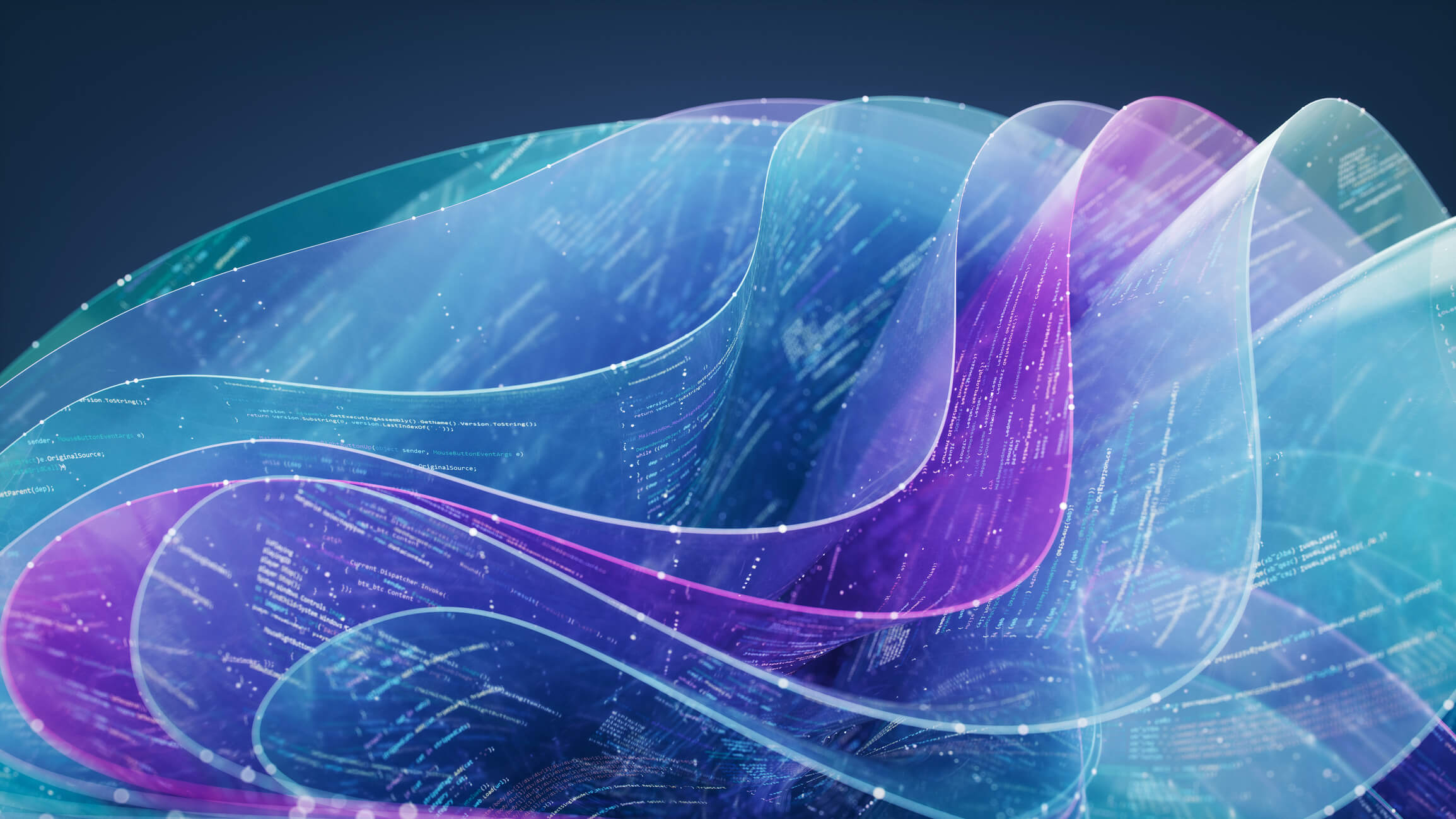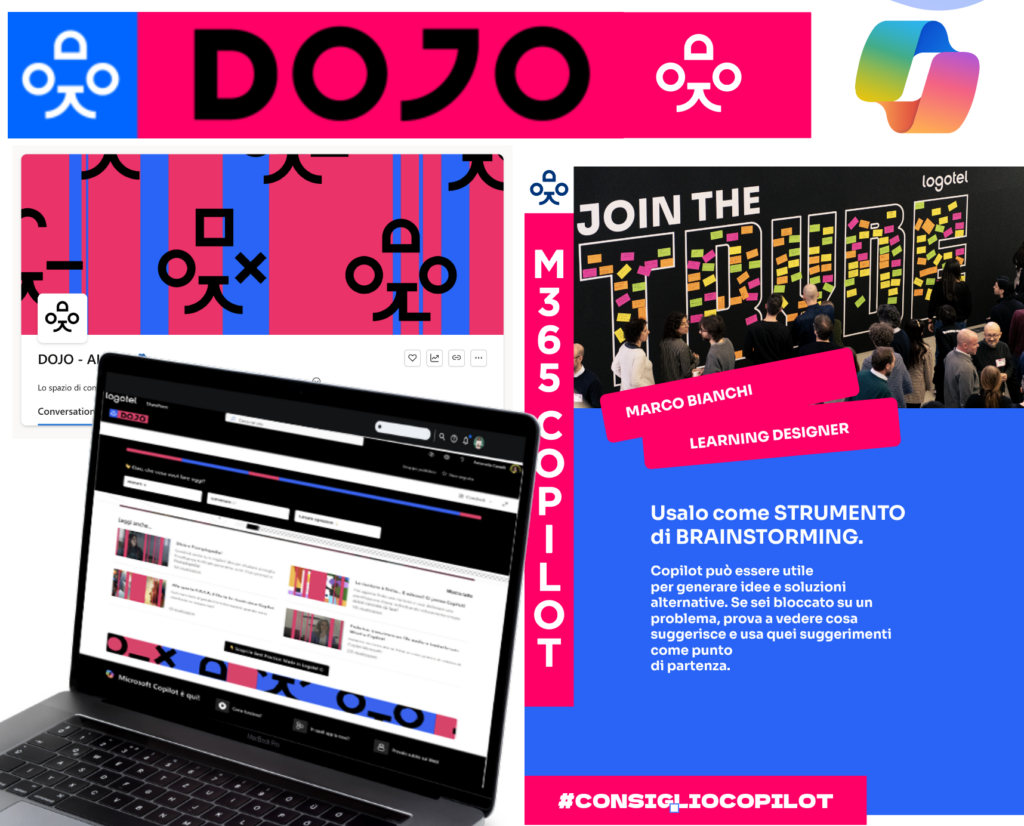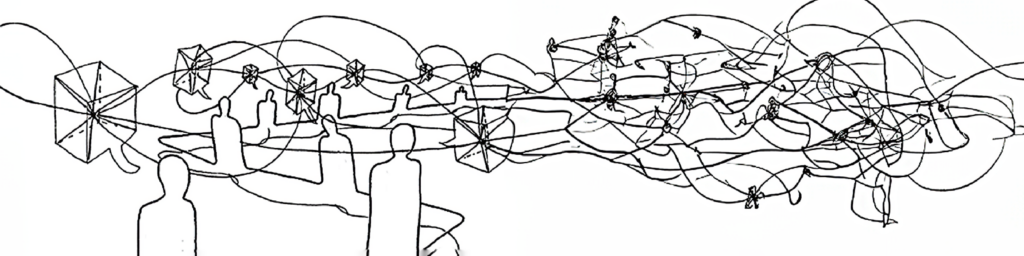Nel mondo dell’intelligenza artificiale generativa, si sta facendo strada un modo completamente nuovo di pensare, organizzare e interpretare dati, idee e relazioni. È un paradigma emergente che supera l’automazione e la produzione di contenuti per abbracciare una dimensione più umana, esplorativa, partecipativa.
È il mondo vibe-first: si affacciano termini come vibe coding, vibe analytics e vibe strategy, si sviluppa un’ecologia di pratiche fondate sull’interazione fluida tra individui, dati e modelli generativi, capaci di trasformare il modo in cui pensiamo, lavoriamo e prendiamo decisioni.
Il contesto: GenAI, partecipazione e spontaneità
L’espressione vibe è tutt’altro che casuale. In inglese rimanda a un’intuizione immediata, a una sensazione condivisa, a una sintonia collettiva. Applicata all’AI, suggerisce un approccio non solo più accessibile e intuitivo, ma anche più vicino alla dimensione umana della collaborazione e della scoperta.
In questo senso, la GenAI sta inaugurando una nuova fase dell’interazione uomo-macchina: non più solo strumenti verticali o modelli predittivi da interrogare, ma agenti intelligenti, con cui “vibrare” intorno a un’intenzione, un’esigenza, un’ipotesi da esplorare.
Colleghi con cui collaborare, superando l’approccio individualistico all’AI — l’AIndividualismo, come lo ha definito la Co-founder, General Manager & Chief Design Officer dell’Independent design company Logotel, Cristina Favini — che è uno dei fattori che sta rallentando la scalabilità dei benefici di questa tecnologia dalla dimensione individuale a quella di organizzazioni e imprese.
Il punto non è più solo ottenere una risposta, ma costruire insieme un contesto. È una logica emergente che si oppone alla rigidità dei dashboard aziendali, ai processi deterministici della business intelligence, ai flussi chiusi delle pipeline digitali. E che invece si muove per associazioni, scoperte, stimoli incrociati.
Vibe coding: programmare come forma di dialogo
Vibe coding è un termine introdotto da Andrej Karpathy, co-fondatore di OpenAI, nel febbraio 2025. Karpathy lo ha definito come “un nuovo tipo di programmazione dove ti lasci completamente andare alle vibrazioni”.
Nel vibe coding, la scrittura di codice — anche da parte di chi non è programmatore — avviene in collaborazione con modelli generativi, attraverso prompt conversazionali. Ma non si tratta solo di farsi scrivere un pezzo di codice. Si tratta di co-creare: suggerire, correggere, affinare in tempo reale. L’intelligenza artificiale diventa così uno sparring partner, un tutor, un acceleratore creativo.
Questo cambia il rapporto tra chi progetta e lo strumento tecnico. Il vibe coding è una forma di empowerment, perché permette a designer, strategist, HR, product manager, persino clienti, di partecipare alla costruzione di strumenti digitali o alla configurazione di sistemi complessi.
Non è più necessario un passaggio intermedio, o una traduzione da “bisogno” a “requisito tecnico”: l’interazione è diretta, iterativa, a tratti ludica. Il coding, in questo contesto, diventa una conversazione.
Dati come partner: la svolta del vibe analytics
Un recente articolo apparso sulla MIT Sloan Management Review introduce il termine vibe analytics. La base di partenza è la stessa logica conversazionale, ma applicata al mondo dell’analisi dei dati.
L’autore dell’articolo spiega che, anziché affidarsi a dashboard statiche e a report settimanali, oggi è possibile interrogare i dati in tempo reale, esplorandoli in modo naturale, spesso con il linguaggio comune.
Ma il passo in avanti non è solo nella semplificazione dell’accesso. È nella possibilità di co-creare insight insieme all’AI. Si lavora per tentativi, si affinano ipotesi, si esplorano correlazioni non previste, si cambiano le domande. Come accade in un brainstorming tra colleghi, la GenAI genera alternative, mette in discussione assunti, suggerisce visualizzazioni nuove o collegamenti con altri set di dati. L’analisi diventa uno spazio di scoperta, non solo un’attività di verifica.
È questo che distingue davvero il vibe analytics dalla business intelligence (BI) tradizionale: l’idea che i dati non parlano solo se interrogati con una domanda chiusa, ma anche se ci si mette a dialogare con essi, con spirito aperto e creativo. Il valore non sta più solo nella precisione del dato, ma nella qualità dell’interazione.
Vibe analytics: alcuni casi d’uso emergenti
Alcuni casi reali aiutano a comprendere il potenziale di questo approccio. Una grande telco asiatica ha introdotto strumenti di vibe analytics in alcuni team di middle management per rispondere più rapidamente a richieste di analisi e insight in contesti operativi. Invece di passare attraverso processi lenti e verticali, i manager possono oggi esplorare le metriche insieme a un copilota AI, comprendere anomalie, formulare ipotesi, simulare scenari.
Un’azienda SaaS americana ha invece sperimentato l’uso di vibe analytics nei team customer success, permettendo agli operatori di costruire rapidamente analisi su gruppi di utenti, performance di prodotto e trend emergenti, dialogando direttamente con il sistema, senza dipendere dai team di data science.
In entrambi i casi, l’AI non sostituisce la competenza umana. Al contrario, la amplifica, la mette in condizione di esprimersi più liberamente. I dati diventano una leva quotidiana, non un recinto tecnico.
Vibe strategy: un nuovo modo di decidere
Ma l’impatto più radicale del paradigma “vibe” si ha forse a livello strategico. Qui, l’AI generativa si propone non solo come supporto, ma come vero e proprio partner per la riflessione. I manager possono esplorare alternative strategiche, valutare scenari, costruire matrici decisionali, generare piani d’azione.
Questo non avviene in sostituzione della leadership o del pensiero critico, ma come amplificazione delle possibilità cognitive. Si superano le rigidità dei modelli lineari, e si entra in una logica più esplorativa, in cui anche l’ambiguità, il dubbio e la complessità possono essere gestiti senza perdere il filo. La strategia diventa un processo più dinamico, condiviso, meno soggetto a bias personali o a logiche gerarchiche.
Implicazioni per le organizzazioni
Adottare il paradigma vibe significa ridisegnare il modo in cui si lavora, si analizza, si decide. Significa passare da modelli basati sul controllo a modelli basati sulla collaborazione. Da sistemi centrati sull’output a processi centrati sull’interazione.
Non è solo una questione di tool, ma di cultura. Le aziende devono prepararsi ad accogliere nuove pratiche, nuovi ruoli e nuove metriche. Per esempio, valutare l’efficacia non solo in termini di efficienza, ma anche di coinvolgimento, esplorazione, apprendimento. Dare spazio all’improvvisazione e alla co-creazione. Accettare che l’AI generativa non funziona solo “a valle” dei processi, ma può agire “a monte”, ispirando nuove direzioni.
Significa anche ripensare la formazione: non basta insegnare a usare i tool, serve aiutare le persone a dialogare con l’AI e a confrontarsi tra loro, a porre buone domande, a navigare tra intuizione e dato.
In questo senso, il paradigma vibe è anche un progetto educativo, che riporta al centro la creatività, la curiosità, la collaborazione e la sperimentazione: ingredienti che si ritrovano nell’approccio community-driven che la design company Logotel applica con efficacia all’AI training e AI adoption, come evidenziano case study come il progetto Dojo sviluppato per Italgas.
Un nuovo lessico organizzativo
Forse il maggiore valore di questo approccio è proprio nella possibilità di riscrivere il linguaggio del lavoro. “Vibe” è un termine che porta con sé leggerezza, empatia, spontaneità. È lontano dal gergo tecnico, ma non è superficiale. Al contrario, apre spazi profondi per innovare le relazioni tra esseri umani e sistemi intelligenti.
Dal vibe coding al vibe analytics sta emergendo una grammatica nuova. Un insieme di pratiche che non negano la tecnologia, ma la umanizzano. Non temono l’automazione, ma la piegano alla collaborazione. Non cercano la perfezione, ma la risonanza.
In un mondo sempre più complesso, l’AI può essere non solo una leva tecnica, ma anche un alleato culturale. A patto che impariamo a vibrare insieme.