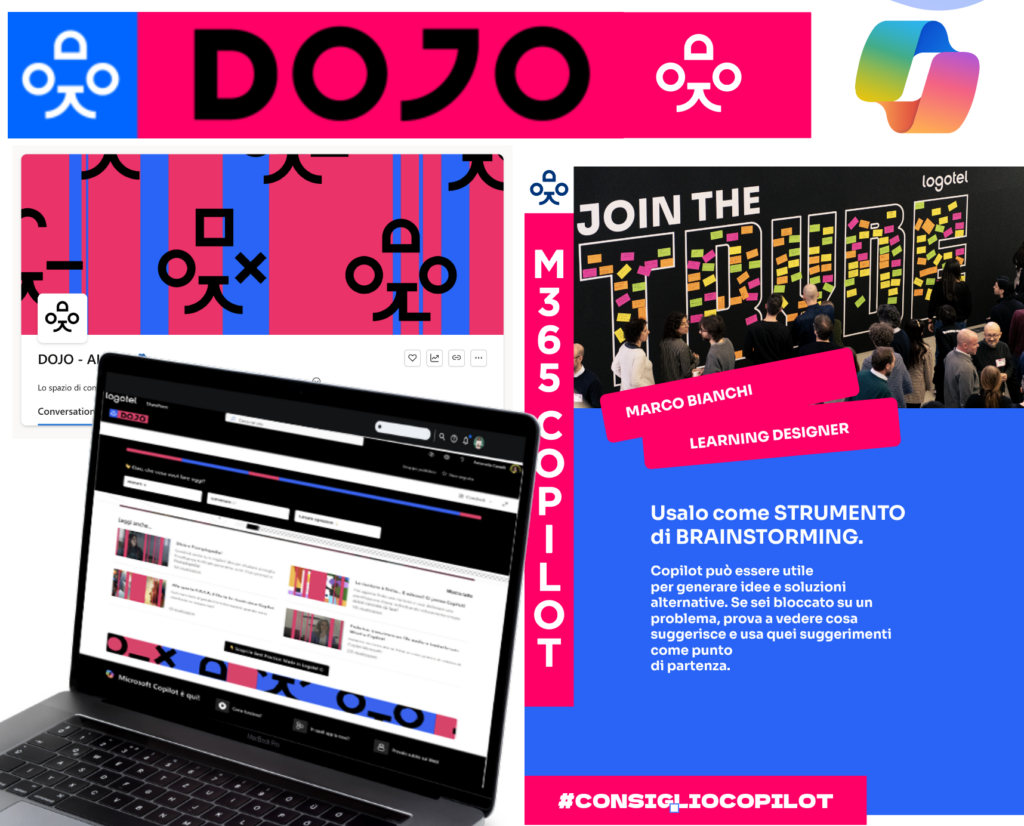Negli ultimi anni, il lavoro ibrido si è affermato come uno dei principali modelli organizzativi del post-pandemia. Spinto inizialmente dall’emergenza sanitaria e successivamente consolidato da alcuni studi e dalle aspettative dei lavoratori, il lavoro che alterna presenza fisica e attività da remoto è diventato per molte aziende e collaboratori la “nuova normalità”.
Ma a distanza di cinque anni, con dati più robusti a disposizione e una maggiore esperienza sul campo, è lecito chiedersi: il lavoro ibrido funziona davvero? Oppure si tratta di una soluzione temporanea, piena di compromessi?
Un recente articolo apparso sull’Harvard Business Review ha rilanciato il dibattito tra sostenitori e detrattori di questa modalità lavorativa, sottolineando come il lavoro ibrido stia indebolendo la collaborazione e la cultura all’interno di aziende e organizzazioni, abbassandone le performance. In questo articolo proviamo a fare il punto sulla questione.
L’ascesa del lavoro ibrido: contesto e aspettative
Dopo la fase emergenziale del Covid-19, molte aziende hanno deciso di mantenere una certa flessibilità nelle modalità di lavoro. Secondo una recente indagine condotta dalla MIT Sloan Management Review, la maggior parte dei lavoratori negli Stati Uniti e nel Regno Unito lavora oggi da remoto circa il 30% del tempo, ma desidererebbe arrivare al 40%. La Generazione Z, in particolare, è quella più orientata alla flessibilità ed è anche la più disposta a cambiare lavoro se le proprie preferenze non vengono rispettate.
Questa domanda crescente di autonomia si è combinata con l’opportunità, per le aziende, di ridurre i costi legati agli spazi fisici e, in alcuni casi, di ampliare il bacino dei talenti potenziali. Il lavoro ibrido è così emerso come la sintesi perfetta tra esigenze organizzative e aspettative individuali: maggiore libertà per i dipendenti, risparmi per le imprese, continuità produttiva per entrambe le parti.
E ad alimentare la fortuna del lavoro ibrido sono arrivati anche studi, come quello dal titolo Hybrid working from home improves retention without damaging performance, pubblicato su Nature.
In questa ricerca, il professore di Economia della Stanford University Nicholas Bloom ha evidenziato come il lavoro ibrido all’interno di un’azienda abbia migliorato la soddisfazione sul lavoro e la retention dei dipendenti, senza avere effetti negativi sulle prestazioni.
I limiti che emergono: collaborazione, performance, cultura
Tuttavia, alcune analisi recenti, tra cui quelle citate nell’articolo Hybrid Still Isn’t Working pubblicato sull’Harvard Business Review, hanno iniziato a mettere in discussione alcune di queste convinzioni. I dati mostrano che il lavoro ibrido e remoto, se non progettato e gestito con regole adeguate, può compromettere la collaborazione, indebolire la cultura organizzativa e persino ridurre la performance dei team.
Uno dei problemi più rilevanti riguarda l’integrazione dei nuovi assunti. Senza la possibilità di osservare direttamente i colleghi o di fare domande al volo, l’apprendimento diventa più lento e frammentato. L’assenza di contesto e di relazioni informali rende più difficile per i nuovi entrati sentirsi parte del gruppo e acquisire le competenze implicite che si trasmettono solo attraverso l’esperienza condivisa.
Anche la collaborazione orizzontale soffre. In ambienti remoti, i lavoratori tendono a focalizzarsi maggiormente sui propri obiettivi individuali, spesso a discapito dell’aiuto reciproco. Le richieste di supporto via chat vengono evase più lentamente, e solo chi ha già un rapporto personale tende a ricevere risposte più tempestive.
Le riunioni online, poi, moltiplicano i partecipanti ma riducono l’efficacia. In molti casi, si trasformano in appuntamenti dispersivi, dove parte del gruppo è distratta o impegnata in multitasking. Questo porta spesso alla necessità di “riunioni post-riunione” per riallineare chi non ha seguito, con un evidente spreco di tempo e risorse e un aumento del meeting hangover, la sensazione di confusione e frustrazione che si prova al termine di riunioni infruttuose.
Gli effetti del lavoro ibrido sulla formazione
Un altro aspetto critico legato al lavoro ibrido riguarda i suoi effetti sulla formazione. È un tema su cui la Independent design company Logotel, che sviluppa progetti di change and learning per clienti di diverse industry e dimensioni, ha avviato da tempo studi e sperimentazioni.
Dalla esperienza e dalle ricerche della design company è emerso che il lavoro ibrido e la digitalizzazione hanno trasformato le modalità di fruizione dei contenuti formativi, che si sono standardizzati sempre di più per raggiungere una popolazione aziendale diffusa in ecosistemi sempre più distribuiti.
Da un lato, ciò ha aumentato i livelli di accessibilità, dall’altro ha però ridotto i livelli di coinvolgimento delle persone, impattando sull’attenzione e la retention delle informazioni apprese e richiedendo ad aziende e organizzazioni di ricalibrare le esperienze formative, adottando nuove prospettive e strategie per renderle più efficaci e di impatto nella nuova logica ibrida.
Il paradosso dell’ibrido: più libertà, meno connessioni
Il lavoro ibrido, per come viene implementato in molte organizzazioni, si trova a vivere un paradosso strutturale. Garantisce più libertà individuale, ma al tempo stesso erode le connessioni sociali e culturali che fanno da collante all’esperienza lavorativa. Meno tempo condiviso fisicamente si traduce in meno opportunità di costruire relazioni, meno cultura trasmessa per prossimità, meno fiducia spontanea.
Secondo l’articolo Hybrid Still Isn’t Working di HBR, molte aziende stanno sperimentando una doppia cultura interna: da un lato, chi è stato assunto prima della pandemia e ha vissuto la cultura “dal vivo”; dall’altro, i nuovi entrati, che ne ricevono solo un’interpretazione parziale e mediata. Questo crea frizioni, incomprensioni e modelli di comportamento divergenti, che a lungo andare possono minare la coesione organizzativa.
Cosa vogliono davvero i lavoratori?
Dalla già citata indagine del MIT Sloan emerge che la maggior parte dei dipendenti non aspira a un lavoro completamente remoto, ma desidera un equilibrio ragionato. Circa il 75% degli intervistati ha dichiarato di non lavorare con la proporzione ideale tra presenza e remoto. E un dato ancora più interessante è che quasi un quarto sarebbe disposto a rinunciare a una parte significativa del proprio stipendio per ottenere maggiore flessibilità.
In particolare, i lavoratori della Gen Z si dichiarano disposti a sacrificare fino al 30% del proprio reddito pur di avere un modello di lavoro coerente con le proprie preferenze. Questo suggerisce che la flessibilità non è vissuta come un semplice “vantaggio accessorio”, ma come una componente centrale del benessere professionale.
Da policy a progettazione: come rendere il modello sostenibile
Affinché il lavoro ibrido diventi davvero sostenibile nel lungo periodo, è necessario passare da una logica emergenziale o permissiva a una logica progettuale. Non basta “lasciare libertà”: serve struttura, chiarezza, coerenza. Le aziende che stanno ottenendo risultati positivi sono quelle che combinano autonomia e disciplina.
Alcuni interventi possibili includono l’adozione di regole chiare per le riunioni (ad esempio, videocamere sempre accese e partecipazione solo se rilevante), l’introduzione di KPI relazionali (che misurino anche il supporto ai colleghi, il mentoring, la collaborazione), e la formazione dei manager per gestire team distribuiti in modo efficace e proattivo.
Anche l’onboarding dei nuovi dipendenti dovrebbe essere ripensato: momenti di presenza obbligatoria, pairing con mentor esperti, presentazione diretta ai colleghi chiave. Il tutto supportato da una trasparenza radicale su processi, responsabilità e obiettivi, per ridurre l’ambiguità che il lavoro distribuito spesso comporta.
Leadership e coesione in ambienti distribuiti
Il successo del lavoro ibrido non dipende solo dalle policy aziendali, ma da un nuovo approccio alla leadership. I manager devono imparare a “vedere da lontano”, a cogliere segnali deboli, a dare feedback in tempo reale, a costruire connessioni intenzionali. Non basta supervisionare il lavoro: bisogna orchestrare fiducia, collaborazione e senso di appartenenza.
Questo significa, tra le altre cose, promuovere occasioni di socialità reale, anche solo periodiche: giornate in ufficio ben organizzate, attività interfunzionali, volontariato aziendale. Perché le relazioni che reggono il lavoro, ancora oggi, si costruiscono nel tempo condiviso e nei gesti informali.
Il lavoro ibrido può funzionare quindi, ma non può più essere lasciato al caso. È tempo di trattarlo come un vero modello organizzativo, da progettare, regolare e allenare. Le aziende che sapranno farlo non solo miglioreranno la produttività, ma costruiranno anche ambienti di lavoro più umani, sostenibili e attrattivi.