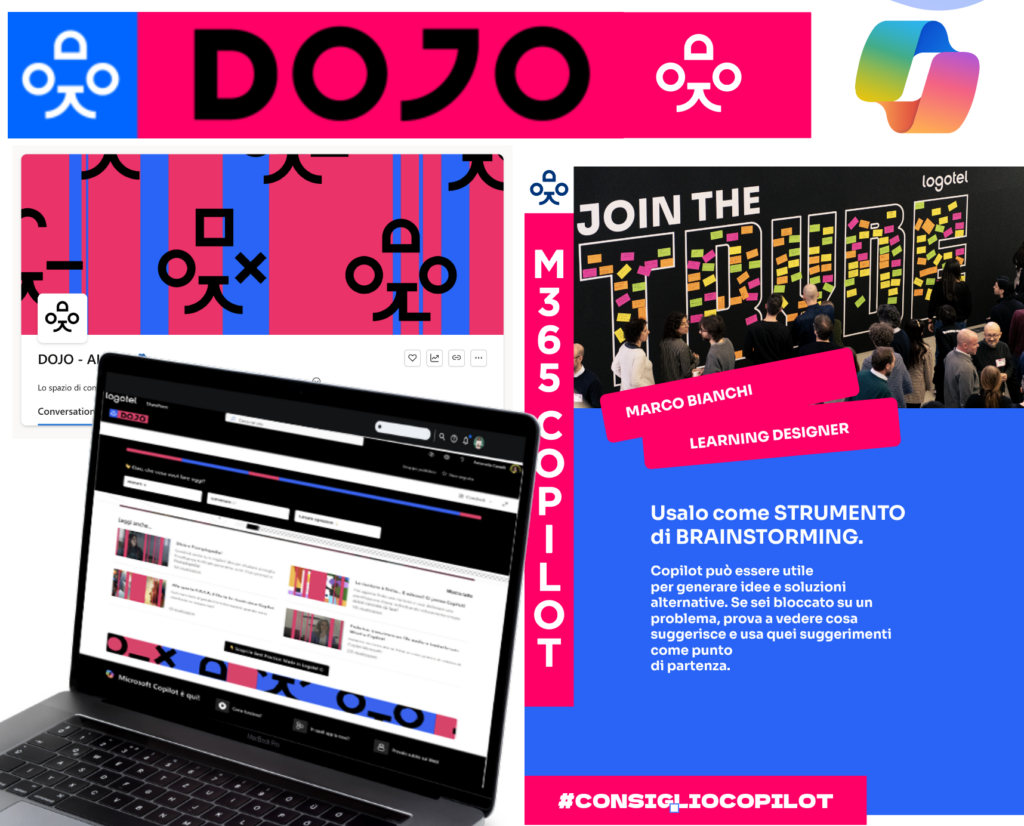Quando si parla di intelligenza artificiale e lavoro, l’immaginario collettivo si divide in due estremi. Da una parte, la visione entusiasta di chi immagina team potenziati da strumenti superumani, in grado di moltiplicare la produttività. Dall’altra, la paura di una sostituzione progressiva del lavoro umano, dove l’AI prende il posto delle persone.
Eppure, come spesso accade nei momenti di grande trasformazione, la realtà è più sottile, meno spettacolare ma molto più interessante: l’AI non ha “stravolto” il lavoro, ma l’ha permeato. In modo silenzioso, quotidiano, quasi invisibile.
Un dato concreto a supporto di questa affermazione arriva dalla ricerca How People Use ChatGPT, il primo report su larga scala su come i circa 700 milioni di utilizzatori del tool di Generative AI lo usano.
In questo articolo riportiamo gli insight più interessanti della ricerca, concentrandoci poi su come ChatGPT viene utilizzato sul lavoro: per quali task, in quali modalità, con quali risultati.
ChatGPT: i numeri di una rivoluzione silenziosa
Per capire davvero come viene usato ChatGPT, OpenAI – l’azienda che lo ha sviluppato – ha condotto la prima analisi scientifica su larga scala: oltre 1,1 milioni di conversazioni analizzate tra maggio 2024 e luglio 2025, attraverso un sistema di classificazione automatizzato che garantisce l’anonimato degli utenti.
Il risultato è una fotografia inedita di un fenomeno che, pur essendo sotto gli occhi di tutti, non era mai stato misurato con questa precisione.
Una crescita senza precedenti
La velocità di adozione di ChatGPT non ha paragoni nella storia della tecnologia. Da 10 milioni a 700 milioni di utenti settimanali in meno di tre anni – dal lancio nel novembre 2022 fino a luglio 2025.
Ma il dato forse più impressionante riguarda l’intensità d’uso: nell’ultimo anno, il volume di messaggi è cresciuto di cinque volte. Segno che non si tratta solo di nuovi utenti che provano lo strumento una volta, ma di persone che lo integrano nella propria quotidianità.
Interessante anche la dinamica geografica: la crescita più rapida si registra nei Paesi a medio e basso reddito, un segnale che l’AI generativa sta democratizzando l’accesso a strumenti un tempo riservati a contesti privilegiati.
Il gender gap? Quasi scomparso
Nei primi mesi dopo il lancio, circa l’80% degli utenti attivi aveva nomi tipicamente maschili. Ma già a giugno 2025, la situazione si è capovolta: il 52% degli utenti ha nomi femminili. È un cambio di paradigma che va oltre la statistica: significa che ChatGPT è uscito dalla nicchia tech ed è diventato uno strumento trasversale, accessibile, quotidiano.
I giovani trainano, ma non sono più soli
Quasi la metà dei messaggi (46%) arriva da utenti sotto i 26 anni. La Generazione Z ha abbracciato ChatGPT come uno strumento naturale, al pari di Google o Instagram.
Ma anche qui, il divario generazionale si sta riducendo. Gli over 35 stanno recuperando terreno, spinti da esigenze pratiche: dalla gestione domestica alla formazione continua, fino al supporto nella comunicazione professionale.
Lavoro o tempo libero? L’equilibrio si è ribaltato
Quando ChatGPT è stato lanciato, l’immaginario collettivo lo vedeva soprattutto come uno strumento professionale. Eppure, i dati raccontano un’altra storia.
Oggi, solo il 27% dei messaggi è legato al lavoro, in netto calo rispetto al 47% di un anno fa. Il restante 73% è uso personale: una percentuale che nel 2024 era ferma al 53%.
Sono varie le ragioni di questo gap, segnalato anche da altri report come l’ultimo Rapporto Coop 2025 sugli stili di vita degli italiani.
Sul fronte individuale, possono esserci ancora resistenze culturali – ricorrere a ChatGPT o a un altro tool di AI può essere visto come una scorciatoia che sminuisce la propria professionalità – e anche timori legati alla presunta inadeguatezza rispetto all’utilizzo delle nuove tecnologie.
Sul fronte delle aziende, invece, possono esserci resistenze a livello organizzativo, scelte strategiche diverse – ad esempio affidarsi ad altri sistemi come Microsoft Copilot, già integrato nella suite adottata da molte imprese – o timori legati alla sicurezza dei dati e al controllo.
Il gap comunque non significa che ChatGPT sia diventato meno utile sul lavoro, ma che l’adozione nella vita quotidiana è esplosa. Le persone lo usano per:
- chiedere ricette personalizzate;
- farsi spiegare concetti complessi;
- ricevere consigli su come affrontare situazioni pratiche;
- supporto nello studio e nella formazione;
- migliorare la scrittura personale (email, messaggi, lettere).
In altre parole: ChatGPT è uscito dall’ufficio ed è entrato in casa.
I tre usi principali: pratici, informativi, creativi
Il report identifica tre macro-categorie che, da sole, coprono il 77% di tutte le conversazioni:
1. Practical Guidance (29%): è la categoria più ampia. Include tutto ciò che riguarda consigli pratici, tutoring, how-to, ideazione creativa. È l’AI come “consulente personale”: aiuta a risolvere problemi concreti, a imparare nuove competenze, a esplorare idee.
2. Seeking Information (24%): ChatGPT come motore di ricerca evoluto. Le persone lo interrogano per ottenere risposte fattuali: “Quando è stata firmata la Costituzione italiana?”, “Qual è la capitale del Ghana?”, “Come funziona la fotosintesi?”. È un uso che si sovrappone a Google, ma con un’interfaccia conversazionale che rende tutto più immediato.
3. Writing (24%): dalla scrittura ex-novo all’editing di testi esistenti. Qui l’AI diventa una sorta di “assistente editoriale”: riscrive, migliora, traduce, semplifica. Non necessariamente per il lavoro, ma anche per email personali, post sui social, messaggi importanti.
Utilizzi meno frequenti
Il report evidenzia anche due usi molto meno frequenti di quanto si potrebbe pensare:
- Il coding rappresenta solo il 4,2% delle conversazioni. Nonostante l’AI sia vista come alleata degli sviluppatori, la maggior parte degli utenti non la usa per programmare. È un uso di nicchia, molto presente su altri chatbot (come Claude di Anthropic), ma minoritario su ChatGPT.
- Le conversazioni legate a relazioni personali o compagnia (relationships e personal reflection) sono solo l’1,9%. Contrariamente a quanto alcuni studi avevano ipotizzato, ChatGPT non viene usato principalmente come “amico digitale” o supporto emotivo. Il suo ruolo è pragmatico, orientato a risolvere problemi concreti.
Come ChatGPT viene usato sul lavoro: dati e insight
Spostando il focus sul terzo circa degli utenti di ChatGPT che utilizzano il tool di Gen AI per lavoro, ciò che emerge non è tanto la quantità di utilizzo, quanto la qualità. L’AI non viene impiegata per sostituire intere professioni, bensì per ridefinire i processi.
Il 40% delle interazioni classificate come lavorative riguarda il writing, e di queste, circa due terzi sono editing, revisione o traduzione di testi già esistenti. In altre parole: non stiamo chiedendo all’AI di inventare, ma di migliorare, riformulare, sintetizzare.
L’AI è diventata una nuova forma di infrastruttura cognitiva: uno strato invisibile che accompagna i processi di pensiero e di produzione, aiutando le persone a scrivere più velocemente, a trovare parole migliori, a spiegare concetti complessi in modo più semplice.
Dall’automazione alla collaborazione
Negli anni passati, l’automazione è sempre stata raccontata come un processo verticale: una macchina che sostituisce un’attività umana. L’arrivo dell’AI generativa ha introdotto un paradigma orizzontale: una macchina che collabora con l’intelligenza umana.
È un cambio di prospettiva radicale. Non parliamo più di sostituzione, ma di co-produzione: l’AI lavora con noi, non per noi. Questo significa che il lavoro umano si sposta: meno tempo speso a produrre contenuti “grezzi”, più tempo per riflettere, scegliere, valutare, dare senso.
Il paper di OpenAI mostra come il 58% delle richieste lavorative ricada in due macro-categorie fondamentali: ottenere, documentare e interpretare informazioni da un lato; prendere decisioni e risolvere problemi dall’altro. Tutti processi che restano umani nel fine, ma diventano più efficienti grazie al supporto algoritmico.
L’AI non prende decisioni al nostro posto: ci aiuta a prepararle meglio.
L’AI come collega silenzioso
Ogni rivoluzione tecnologica cambia non solo ciò che facciamo, ma anche come pensiamo. L’intelligenza artificiale non è diversa.
Chi lavora con strumenti come ChatGPT sa che, dopo un po’, il confine tra “pensare con” e “pensare attraverso” la macchina si fa sottile. L’AI non è un semplice tool: è un interlocutore cognitivo.
Lo confermano anche i dati sulla soddisfazione degli utenti: i messaggi classificati come “Asking” (richieste di consigli e supporto decisionale) ricevono valutazioni più alte rispetto ai messaggi “Doing” (richieste di task da completare). Gli utenti premiano l’AI quando li aiuta a pensare meglio, non solo a fare più velocemente.
Nel mondo del lavoro, questo si traduce in un fenomeno nuovo: la collaborazione ibrida tra persone e agenti artificiali. Si chiedono suggerimenti, si esplorano alternative, si fanno simulazioni. L’AI diventa un assistente sempre presente – non tanto un sostituto, ma un’estensione.
In un certo senso, ogni lavoratore oggi ha accanto un “collega invisibile”: un partner digitale che non dorme, non si stanca, non giudica, e soprattutto non smette di imparare.
Lavorare con l’AI cambia il modo di lavorare
Ciò che lo studio di OpenAI mette in luce è che la vera trasformazione non riguarda il tipo di compiti svolti, ma il modo in cui vengono svolti. L’AI entra nei processi come un acceleratore di micro-decisioni quotidiane:
- aiuta a scrivere un’email più chiara;
- suggerisce un tono di voce più efficace;
- traduce un concetto tecnico in linguaggio accessibile;
- riassume una riunione in punti chiave.
Sono task che anche altri tool di Gen AI, come ad esempio Microsoft Copilot, consentono di fare. Ed è in queste attività micro, distribuite, continue, che si produce il vero cambiamento.
Il risultato è una produttività diffusa: un miglioramento leggero ma costante, che si somma giorno dopo giorno. E che, nel tempo, ridisegna i flussi di lavoro.
Non tutto ciò che è generato è valore
C’è, tuttavia, un rischio già visibile: quello che alcuni analisti hanno definito AI workslop – un eccesso di contenuti in apparenza validi, ma in realtà senza sostanza, che anziché aiutare a snellire i processi lavorativi comportano un aggravio di tempo e generano frustrazione.
Se da un lato l’AI amplifica la nostra capacità produttiva, dall’altro rischia di alimentare una cultura della quantità a scapito della qualità.
Ecco perché la vera sfida non è “usare l’AI di più”, ma usarla meglio e in modo diverso. Un cambio di paradigma che la Independent design company logotel riassume così: da +AI a AI+.
Non basta cioè aggiungere l’AI a ciò che facciamo. Per generare vero valore per persone, aziende e organizzazioni bisogna usarla per immaginare, progettare e realizzare una nuova generazione di ecosistemi collaborativi tra persone, team e AI.
Dati, giudizio e fiducia
L’intelligenza artificiale non chiede solo nuove competenze tecniche, ma una nuova etica del lavoro cognitivo: imparare a fermarsi, a validare, a selezionare. Serve utilizzarla con consapevolezza, con senso critico, con la capacità di distinguere tra ciò che serve e ciò che distrae.
L’AI sa riconoscere pattern, ma non sa interpretare il contesto. È qui che il ruolo umano resta insostituibile. L’analisi dei dati diventa utile solo se accompagnata da giudizio, esperienza, sensibilità.
Il vero valore dei processi lavorativi non sta più nella capacità di accumulare informazioni, ma nella capacità di dare loro significato.
Per questo, l’AI non riduce la necessità di pensiero critico: la moltiplica.
Ogni nuova possibilità tecnologica apre anche un nuovo rischio di errore, di bias, di distorsione. E la fiducia – tra persone, tra organizzazioni, tra esseri umani e macchine – diventa la vera moneta del lavoro del futuro.
Verso un nuovo equilibrio
L’AI è già dentro i processi, ma siamo solo all’inizio di una fase di apprendimento collettivo.
Le aziende che sapranno trarne vantaggio non saranno quelle che automatizzeranno di più, ma quelle che sapranno orchestrare meglio: combinare intelligenza umana e artificiale in modo armonico, trasformando la tecnologia in leva di crescita e non in scorciatoia.
Per farlo, serviranno nuove competenze trasversali: AI fluency, capacità di prompt design, sensibilità etica, comunicazione tra team umani e digitali. Ma, soprattutto, servirà un nuovo modo di guardare al lavoro: meno centrato sul controllo, più orientato all’apprendimento continuo.
L’AI è già entrata nei flussi, nei processi, nelle abitudini. Ha cambiato il ritmo delle giornate, la forma dei documenti, il tempo delle decisioni.
Non è la fine del lavoro umano, ma la nascita di una nuova relazione con la tecnologia – più simile a un dialogo che a un comando. E come ogni dialogo autentico, richiede ascolto, attenzione e responsabilità.
Perché alla fine, l’AI non lavora al posto nostro: lavora con noi. E il suo vero potenziale non sta nella velocità con cui scrive, ma nella profondità con cui ci invita a ripensare cosa significa davvero lavorare bene.